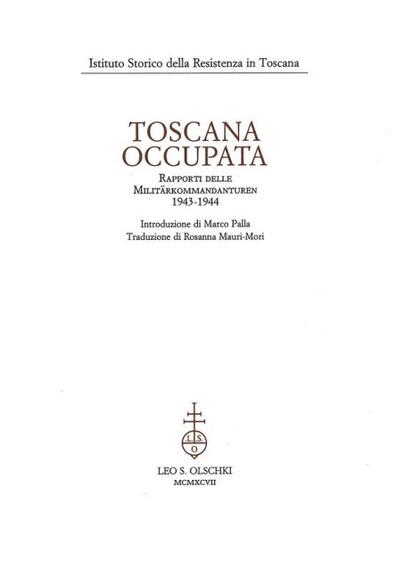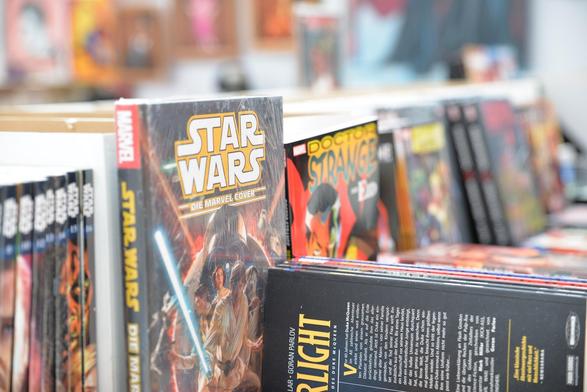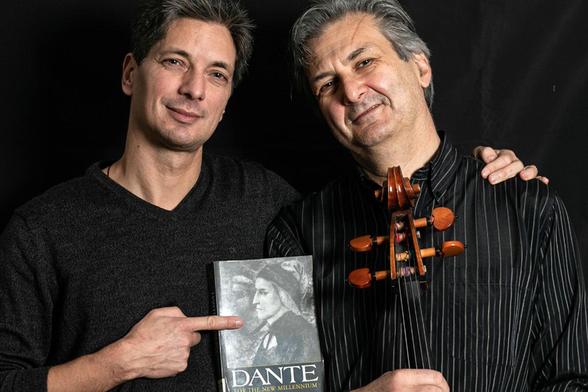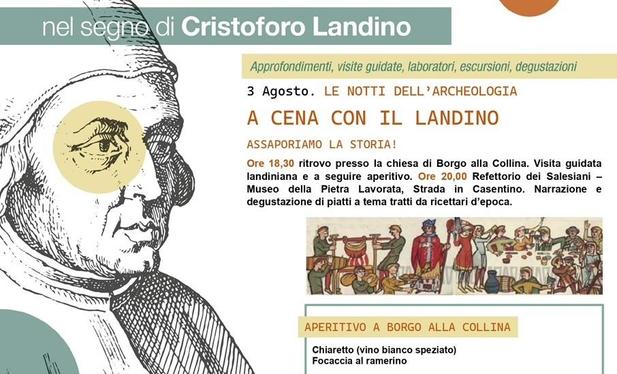Nell’Alto Casentino, sul Monte Morello, così come nell’area delle Colline Metallifere e della Bassa Maremma vedevano la luce sin dal settembre-ottobre 1943 le prime formazioni ribelli
Il rovinoso dissolversi dell’autorità di governo – «lo stato italiano non c’era più», ricorda laconicamente l’azionista Enzo Enriquez Agnoletti, «di questo tutti ne erano testimoni» <187 – permetteva infatti alle pur deboli forze dell’antifascismo organizzato di proporsi come un’alternativa chiara e netta al risorgere dell’ultimo fascismo, «accetta[ndo] la sfida della guerra civile» lanciata con la costituzione della Repubblica sociale e il tentativo di mobilitazione dell’intero corpo sociale da questa imposto <188.
Sin dalle prime settimane seguenti l’armistizio, il nascente movimento resistenziale si sarebbe comunque dimostrato fenomeno eterogeneo e dai contorni quanto mai sfuocati, destinato inevitabilmente a subire, al pari dell’azione repressiva volta a contrastarlo, i contraccolpi della guerra combattuta sul fronte meridionale, che «non poco influirono» sulla «formazione, l’incremento o la dispersione delle bande partigiane» <189. Al pari dell’intenso lavorio condotto dai partiti antifascisti per gettare le basi delle future formazioni partigiane, era la stessa società civile toscana, superato il trauma iniziale, a mostrarsi tutt’altro che immobile: fondamentale sarebbe infatti apparso, in primo luogo, il diffuso aiuto e sostegno materiale spontaneamente offerto dalla popolazione locale ai militari italiani sbandati e ai prigionieri di guerra alleati evasi dai campi di detenzione, rifugiatisi in gran numero nelle campagne. Dalla sua tenuta nei pressi di Chianciano, appuntava il 19 settembre 1943 la scrittrice inglese Iris Origo, attenta testimone del conflitto combattutosi in Toscana:
“Ogni giorno [prigionieri alleati] arrivano in fattoria o alle varie case coloniche, a piccoli gruppi; chiedono la strada per il Sud, si fanno dare da mangiare e poi proseguono. La maggior parte dei coloni, pur essendo consci del pericolo che corrono, li accolgono e li ospitano con gioia” <190.
Pur non configurandosi necessariamente come un consapevole moto di resistenza civile, questa insostituibile «rete protettiva» si sarebbe ben presto estesa alle prime formazioni partigiane, garantendo in alcuni casi un radicamento sul territorio tale da permetterne la sopravvivenza durante il primo, difficile inverno alla macchia. Un rapporto, quello tra comunità locali e Resistenza, comunque complesso e non privo di diffidenze e battute d’arresto, impostesi in particolare a seguito della prime stragi e violenze perpetrate da fascisti e truppe occupanti, tese in alcuni casi a spezzare il sostegno della popolazione isolando di conseguenza le bande <191.
In queste fase aurorale erano comunque le aree più interne e appartate della regione, lontane dall’occhiuta sorveglianza nazifascista, a costituire l’habitat delle prime aggregazioni di uomini datisi alla macchia. Nell’Alto Casentino, sul Monte Morello, così come nell’area delle Colline Metallifere e della Bassa Maremma – per limitarci ad alcune della località più precocemente interessate dal fenomeno resistenziale – vedevano la luce sin dal settembre-ottobre 1943 le prime formazioni ribelli, passate in alcuni casi immediatamente all’azione. Comprensibilmente più lento si sarebbe invece dimostrato lo sviluppo di un’opposizione armata al nazifascismo nelle province costiere, anche in virtù della maggior presenza tedesca <192.
Accanto a una sparuta ma significativa presenza di militanti antifascisti, alcuni dei quali reduci dalle decisive esperienze vissute nel conflitto civile spagnolo o nel maquis francese <193, queste prime bande si componevano inizialmente soprattutto dei molti militari sbandatisi dopo l’8 settembre, ben intenzionati a sottrarsi agli insistenti bandi di presentazione disposti dalle autorità tedesche e poi italiane <194. A una tale ossatura si sarebbero aggiunti, nel corso dei mesi successivi, i sempre più numerosi renitenti alle leve fasciste e al servizio del lavoro, creando quella base di massa indispensabile per lo sviluppo della resistenza armata <195. Per la gran parte di questi uomini, l’aggregarsi, anche casualmente, in piccoli gruppi rispondeva comunque almeno inizialmente a motivazioni di conservazione e di autodifesa, ben sintetizzabili – nella penetrante definizione di Santo Peli – in una vera e propria «resistenza alla guerra», presupposto spesso indispensabile a una «partecipazione diretta alla guerra partigiana vera e propria» <196. Il nascondersi, sottraendosi a una netta scelta di campo in condizioni di semiclandestinità, si sarebbe infatti dimostrata una «condizione […] scomoda, pericolosa e umiliante», spesso accettata «perché ritenuta provvisoria». Da qui, precisa Maurizio Fiorillo, la «volontà» per alcuni di «uscire dalla passività» e dall’inazione, contrapponendosi alla minaccia nazifascista attraverso la resistenza armata <197.
A questa miriade di gruppi «che potremo definire prepolitici», animati da un diffuso spontaneismo ma spesso incapaci di condurre forme di lotta non episodiche, si sarebbe nel corso dei mesi saldata la febbrile attività organizzativa e di coordinamento portata avanti dagli esponenti locali dei partiti antifascisti, sempre più decisiva per infondere continuità, direzione e visibilità al movimento resistenziale <198. Un confronto certamente non privo di reticenze e tensioni, destinato a ricomporsi solo a ridosso della liberazione: a una mentalità della guerriglia «sull’uscio di casa», espressione di necessità di autodifesa marcatamente localistiche, si contrapponevano le potenzialità di una lotta di più ampio respiro e politicamente consapevole, gravata però da maggiori incertezze e crescenti rischi per la popolazione locale, esposta alla dura reazione nazifascista <199.
Portatrici di progetti politici assai diseguali, da raggiungersi attraverso forme e metodi di lotta diversi, le stesse forze politiche antifasciste avrebbero comunque impostato la loro azione nella consapevolezza – già lo ricordavamo – di «rendere irreversibile una radicale discontinuità rispetta al regime fascista» <200, in netta opposizione al concomitante tentativo di radicamento portato innanzi del fascismo repubblicano, «arma pericolosissima in mano ai tedeschi» <201.
Alle autorità del tradimento – precisava Enriques Agnoletti in un importante contributo pubblicato sul primo numero della rivista Il ponte – bisognava opporre l’autorità, clandestina ma conosciuta, degli organi della rivolta popolare e democratica, […] bisognava insomma in qualche modo partecipare all’autorità governativa <202.
«Combattere subito i fascisti», al pari e più dei tedeschi, era la posizione espressa a chiare lettere già nel novembre 1943 da Carlo Ludovico Ragghianti, responsabile militare del Partito d’Azione (PdA) a Firenze <203. Ma se per i vertici del PdA l’impegno sul campo si sarebbe in special modo concretizzato, almeno inizialmente, in una forte azione propagandistica e organizzativa, per il Partito comunista l’«agire subito», opponendosi frontalmente all’autorità fascista in quella guerra civile pur formalmente rigettata dalla propaganda comunista, avrebbe rappresentato un imperativo non più dilazionabile <204.
[NOTE]
187 E. ENRIQUES AGNOLETTI, La politica del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, cit., p. 417. Sulle ricadute di un tale «venir meno di riferimenti non solo istituzionali, ma anche ideologici ed etici» cfr. S. PELI, La Resistenza in Italia, cit., p. 18.
188 S. NERI SERNERI, Guerra, guerra civile, liberazione, cit., pp. 543-546. Sulla «costituzione della RSI» quale «origine» della guerra civile si veda R. DE FELICE, La guerra civile, cit., p. 69.
189 G. PERONA, La Toscana nella guerra e la Resistenza: una prospettiva generale, cit., pp. 76-77. Pur in assenza di un aggiornato lavoro d’insieme, che rilegga criticamente la storia della Resistenza toscana, disponiamo comunque di un’amplissima bibliografia di contributi di taglio locale, cui daremo via via conto, e di alcuni validi saggi di respiro regionale. Limitatamente a questi ultimi, si segnalano in particolare i contributi pubblicati in M. PALLA (a cura di), Storia della Resistenza in Toscana, cit. Meno recenti, seppur non privi di utili spunti, sono invece G. VERNI, La Resistenza in Toscana, cit. e L. CASELLA, La Toscana nella guerra di liberazione, cit.. Per una più ampia rassegna bibliografica si rimanda a N. LABANCA, Resistenza/resistenze. Un bilancio tra discorso pubblico e studi storici, in C. FUMIAN – M. FIORAVANZO (a cura di), 1943: strategie militari, collaborazionismi, resistenze, cit., pp. 27-75.
190 I. ORIGO, Guerra in Val d’Orcia, cit., p. 78.
191 Su questi aspetti un solido punto di partenza rimane A. BRAVO, Resistenza civile, in E. COLLOTTI – R. SANDRI – F. SESSI (a cura di), Dizionario della Resistenza, Vol. I. Storia e geografia della Liberazione, Einaudi, Torino 2000, pp. 268-282. Riguardo al «problema dei “costi” umani della Resistenza», su cui torneremo più volte a confrontarci, cfr. S. PELI, La Resistenza in Italia, cit., pp. 238-249 e ID., La Resistenza difficile, Franco Angeli, Milano 1999, pp. 35-57.
192 G. VERNI, La resistenza armata in Toscana, cit., pp. 204-206. Per un’agile ma attenta ricostruzione sulle «origini» del movimento partigiano vedi S. PELI, La Resistenza in Italia, cit., pp. 15-54.
193 S. PELI, Storie di Gap, cit., pp. 39-42. Cfr. inoltre E. ACCIAI, Ieri in Spagna, oggi in Europa. Le rotte dei reduci italiani delle Brigate Internazionali in un continente in Guerra (1936-1945), in F. BERTAGNA – F. MELOTTO (a cura di), Resistenza e guerra civile, cit., pp. 21-41.
194 «I militari italiani di qualsiasi grado – si legge in una delle prime ordinanze emesse da Kesselring – inclusi quelli i cui reparti sono già stati disciolti, debbono presentarsi immediatamente in uniforme al più vicino comando militare tedesco. Ogni militare che non eseguisce il presente ordine verrà giudicato dai tribunali militari tedeschi», in Un bando del Comando Supremo delle truppe germaniche, «La Nazione», ed. di Firenze, 17 settembre 1943.
195 Sulla «scelta partigiana», non scontata e spesso travagliata, vedi in particolare C. PAVONE, Una guerra civile, cit., pp. 23-41 e L. BALDISSARA, I “resistenti” prima della Resistenza, in L. ALESSANDRINI – M. PASETTI (a cura di), 1943: guerra e società, Viella, Roma 2015, pp. 17-33.
196 Le citazioni sono rispettivamente tratte da S. PELI, La Resistenza difficile, cit., p. 37 e S. PELI, La Resistenza in Italia, cit., p. 6. In tal senso si veda anche G. PERONA, La Toscana nella guerra e la Resistenza: una prospettiva generale, cit., p. 87 e, per un interessante caso locale, R. GIACOMINI, La Resistenza come rifiuto della guerra, «Storia e problemi contemporanei», VIII (1995), n. 15, pp. 275-295.
197 M. FIORILLO, Uomini alla macchia. Bande partigiane e guerra civile. Lunigiana 1943-1945, Laterza, Roma 2010, p. 51.
198 Per il contesto toscano si richiama in particolare G. PERONA, La Toscana nella guerra e la Resistenza: una prospettiva generale, cit., pp. 91-95. Più in generale vedi S. PELI, La Resistenza difficile, cit., pp. 34-54.
199 G. VERNI, Appunti per una storia della Resistenza nell’aretino, in I. TOGNARINI (a cura di), Guerra di sterminio e Resistenza. La Provincia di Arezzo 1943-1944, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1990, p. 126.
200 S. PELI, La Resistenza in Italia, cit., p. 6.
201 E. ENRIQUES AGNOLETTI, La politica del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, cit., p. 417.
202 Ibid..
203 Rapporto al Comitato Centrale del Partito d’Azione in Roma, cit., p. 4. Sulla figura di Ragghianti e l’organizzazione del PdA a Firenze cfr. C. FRANCOVICH, La Resistenza a Firenze, cit., pp. 76-80.
204 S. PELI, La Resistenza in Italia, cit., pp. 44-45. Per una concettualizzazione e contestualizzazione di lungo periodo della categoria di guerra civile, tra antifascismo e Resistenza, si veda S. NERI SERNERI, «Guerra civile» e ordine politico. L’antifascismo in Italia e in Europa tra le due guerre, «Italia contemporanea», (2002), n. 229, pp. 601-623.
Lorenzo Pera, La lunga RSI: violenza e repressione antipartigiana del fascismo repubblicano toscano, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Firenze – Università di Siena, 2022
#1943 #alleati #Alto #Aretino #bassa #CarloLudovicoRagghianti #Casentino #CollineMetallifere #EnzoEnriquesAgnoletti #ex #fascisti #Firenze #IrisOrigo #LorenzoPera #Lunigiana #Maremma #militari #Monte #Morello #ottobre #partigiani #prigionieri #province #Resistenza #settembre #tedeschi #Toscana