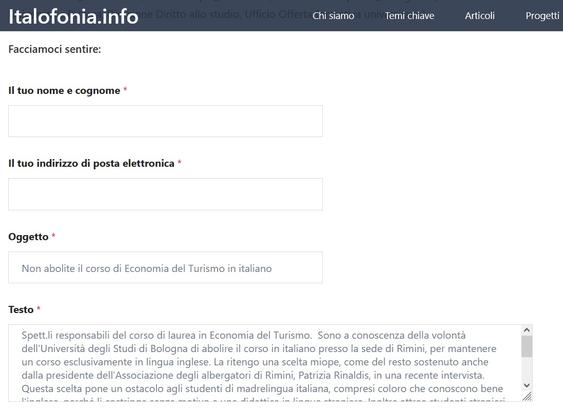Di Antonio Zoppetti
Tra le tante sciocchezze che circolano sulla questione dell’abuso dell’inglese, ce n’è una particolarmente fastidiosa che circola negli ambienti anglomani, secondo la quale l’ostentazione degli anglicismi sarebbe inversamente proporzionale alla buona conoscenza di quella lingua.
La tesi di questa bizzarra panzana parte dal presupposto che chi padroneggia l’inglese non lo userebbe a sproposito e, in questa visione, l’idea caricaturale che emerge dell’itanglese è quella del linguaggio di Alberto Sordi degli anni Cinquanta, che si riempiva la bocca di mamy, papy e pseudoanglicismi come awanagana per darsi un tono, in modo ridicolo, per ostentare la padronanza di una lingua che non conosceva affatto.
Naturalmente questa patetica ricostruzione delle cose non sta né in cielo né in terra, e chi sta cancellando l’italiano per sostituirlo con l’inglese non ha un problema con la lingua di Albione, ma con la nostra: l’italiano, vissuto come lingua antiquata e inferiore.
La diglossia che fa dell’inglese una lingua superiore nasce negli ambienti colti, nelle elite, nelle classi egemoni e nei progetti politici che puntano ad affermare l’inglese come lingua “franca” e internazionale, anche se non c’è nulla di “franco” in tutto ciò.
L’inglese proclamato a torto “lingua franca”
L’espressione “lingua franca” un tempo designava un sistema di comunicazione commerciale diffuso nel Mediterraneo tra europei e islamici che era caratterizzato da un lessico soprattutto italiano e spagnolo con anche qualche arabismo, e da una grammatica estremamente semplificata. Per estensione, come riporta il vocabolario Treccani, indica “anche le lingue creole, miste di elementi europei e indigeni, e tutti quei tipi di lingue miste sorte per necessità pratiche di comunicazione in zone o ambienti dove vengono a contatto gruppi linguistici profondamente diversi”.
Con un piccolo magheggio, in epoca di globalizzazione è invece l’inglese a essere proclamato “lingua franca”; peccato che – per chiamare le cose con il loro nome – l’inglese a cui ci si riferisce è la lingua naturale dei popoli dominanti, nella sua interezza, senza alcuna semplificazione, il che ha a che fare con processi più simili al colonialismo culturale e linguistico che non a un sistema di comunicazione neutro. E infatti nessuno definirebbe lo spagnolo coloniale, o prima ancora il latino dei popoli conquistati e romanizzati, una lingua “franca”, questi fenomeni erano invece l’imposizione della propria lingua ai Paesi sottomessi. L’attuale affermazione dell’angloamericano in contesti come la scienza o l’Ue (da cui il Regno Unito è uscito) segue questo schema coloniale più che il concetto di “lingua franca”, e rappresenta un giro d’affari dal valore incalcolabile per chi impone agli altri la propria lingua e non si deve preoccupare di studiarne altre.
L’angloamericano diventa in questo modo una lingua di prestigio che schiaccia le lingue locali “inferiori” e sottrae loro terreno in una moderna diglossia neomedievale (come denuncia il lingusta tedesco Jurgen Trabant) che riduce le lingue nazionali a dialetti di un mondo che pensa e parla inglese, un mondo che si vuole costruire e legittimare – talvolta chiamato Occidente – e che non tiene conto del fatto che la conoscenza di questo inglese non appartiene al popolo (se non in alcuni Paesi come quelli scandinavi o del Nord-Europa), ma a un’oligarchia e a una minoranza.
L’effetto collaterale di questo progetto politico su cui gli investimenti sono enormi – l’Europa spende miliardi per creare le nuove generazioni bilingui a base inglese sin dai primi anni di scuola – è che gli anglicismi finiscono poi pe penetrare in tutte le lingue del mondo, e dai settori specialistici della tecnica, della scienza o del lavoro si estendono alla lingua comune con un’intensità che ha portato alla coniazione di concetti come il franglais in Francia, lo spanglish per i Paesi ispanici, il Denglisch in Germania… e in questo “tsunami anglicus”, come lo ha chiamato Tullio De Mauro, persino le popolazioni che possiedono altri alfabeti – dal cinese al russo, dal coreano al giapponese – fanno i conti con un’invasione di anglicismi che arrivano dall’alto e snaturano le risorse linguistiche locali.
L’itanglese è la lingua di una classe dirigente anglomane
In Italia la situazione degli anglicismi è ben più pesante che in altri Paesi, e il motore di questo fenomeno non è certo determinato dagli awanagana di macchiette come Nando Mericoni di Alberto sordi. Quando vengono trapiantate espressioni inglesi come lockdown o fake news, che si radicano in un baleno, sono i giornalisti a riprendere le parole d’oltreoceano e a usare solo quelle fino a indottrinare la popolazione che alla fine non può che ripetere quel che passa il convento mediatico. Questi trapianti non arrivano affatto da chi l’inglese non lo conosce, tutto il contrario: chi è avvezzo a nutrirsi (culturalmente) pescando solo negli ambienti anglofoni (o anglomani) finisce per ricorrere all’inglese in modo sempre più spontaneo e a considerare gli anglicismi di volta in volta più solenni, più tecnici, più moderni, più internazionali… e in buona sostanza alimenta la “diglossia lessicale” per cui ogni parola inglese, e persino pseudoinglese, finisce per essere preferita alle alternative italiane (quando ci sono), che di conseguenza regrediscono.
Affermare che chi conosce l’inglese non lo usa al posto dell’italiano non è solo una banalizzazione che rivela tutta l’incapacità di comprendere i reali meccanismi dei cambiamenti linguistici del Duemila, è funzionale all’affermazione del globish come lingua “franca”, in un ribaltamento della realtà dove per salvaguardiare la nostra lingua non si dovrebbe investire sull’italiano, ma tutto il contrario, bisognerebbe invece saper meglio l’inglese. Anche un bambino capisce che questa idiozia non sta né in cielo né in terra, ma per chi ha qualche difficoltà di comprendonio vorrei riportare un esempio che mi ha segnalato un luminare della fluidodinamica, Luigi Quartapelle Procopio, professore associato del Politecnico di Milano, autore di pubblicazioni in italiano e in inglese che opera nel panorama scientifico internazionale. Mi ha rigirato con sdegno – visto che è stato uno dei più agguerriti firmatari della petizione per non estromettere l’italiano dalla formazione universitaria – una comunicazione che gira in questi giorni tra i docenti di quell’ateneo e che voglio virgolettare:
“(…) Da questo autunno attiveremo una serie di iniziative di comunicazione su intelligenza artificiale (AI) con l’intento di accentrare l’attenzione del territorio milanese e lombardo sul nostro ateneo. In questo momento in cui qualunque struttura cerca di posizionarsi come l’interlocutore di riferimento per AI, il polimi non poteva sottrarsi dal proporre un programma di alto profilo.
Il target di queste iniziative è duplice. Avremo degli awareness panel su tematiche di interesse sociale diretti principalmente alla cittadinanza con speakers di eccellenza. Questi includeranno, in ordine, AI and Education, AI Risks and Regulation, AI and Health, AI and Sustainability, e, infine, un panel su AI Generativa il cui target sarà, diversamente dai precedenti, più orientato alle aziende. Avremo inoltre seminari scientifici il cui target è sia la comunità scientifica – non strettamente solo quella tecnica/tecnologica – sia gli studenti che le aziende che fanno ricerca e sviluppo. (…) Vi allego il programma per la fine del 2024, mentre il programma per il 2025 sarà presentato durante il primo awareness panel (12 novembre, su AI and Education). Ogni evento richiederà una registrazione online, il cui link potrà essere trovato nelle locandine che verranno piano piano pubblicate sui canali media dell’ateneo.”
Naturalmente il programma allegato è in inglese, perché il Politecnico di Milano è l’ateneo che ha dato via al progetto pilota per estromettere l’italiano dall’insegnamento universitario. E la lingua più naturale e spontanea di chi ha scelto l’inglese come lingua “franca” dell’università ha una base italiana (più spontanea che scolarizzata, a giudicare da come scrive il mittente) in cui percolano i concetti e le espressioni in inglese che si sono normalizzati (almeno nella testa dello scrivente) e fissati in espressioni stereotipate intoccabili: AI invece di IA, la ripetizione meccanica di target, i concetti in inglese invece che in italiano che introducono Education, Regulation o Healt al posto di istruzione, regolamento o salute. E nell’anglicizzazione selvaggia queste parole si scrivono con le maiuscole all’americana, mentre anche la “s” del plurale viene normalizzata (speakers) alla faccia delle norme dell’italiano che si controlla pochino e che comunque poco interessa.
Dunque, in casi come questo è la scarsa attenzione per la propria lingua madre che produce simili comunicazioni, dove l’ostentazione dell’inglese sembra semmai inversamente proporzionale all’amore e alla conoscenza dell’italiano.
Il fatto grave è che questo tipo di comunicazione non è solo in voga tra gli anglomani, è quella che si sta imponendo nell’Università, tra gli addetti ai lavori, che viene ormai accettata e preferita negli ambienti culturali, tecnici, istituzionali e soprattutto viene diffusa e legittimata in un’educazione all’inglese rivolta a tutti: “il target di queste iniziative” non è “duplice”, come si legge nel documento, ma almeno “triplice”: il terzo obiettivo implicito (e non dichiarato) è quello di rendere questa lingua ufficiale, e di affermarla non solo sul “territorio milanese” ma anche nella testa delle giovani generazioni che si formano, e che costituiscono il nostro futuro (anche linguistico, oltre che culturale e produttivo).
Chi studia in inglese è portato a pensare in inglese e a esprimersi con concetti in inglese, invece che in italiano, con la conseguenza della perdita della terminologia e della concettualizzazione nella nostra lingua. Nei Paesi del Nord Europa dove il progetto del globalese nelle università si è quasi compiuto, si sta cominciando a riflettere con preoccupazione sugli effetti nefasti di questa politica. L’inglese come lingua dell’università o della scienza non si è rivelato un processo “aggiuntivo”, una risorsa in più che si affianca alla cultura nativa, bensì un processo sottrattivo che ha fatto retrocedere la lingua nazionale e ha portato alla regressione del lessico e della lingua nativi. E quindi, dalla Svezia all’Olanda, si assiste a una messa in discussione di queste politiche e a una marcia indietro.
In Italia, invece, si procede ciechi e bendati verso l’anglificazione dell’università, e il nostro modo di essere “internazionali” non significa guardare a ciò che avviene all’estero, anche a proposito delle politiche linguistiche di Paesi come la Francia, la Spagna, la Svizzera o l’Islanda; significa invece assumere e sposare il punto di vista degli “americani” (la parte per il tutto e cioè il monolinguismo invece del plurilinguismo), incuranti del fatto che questa strategia ci sta annichilendo. E così, un altro professore di fisica dell’Università di Firenze mi scrive affranto:
“Anche qui a Firenze stiamo andando verso una laurea specialistica in fisica in inglese. Ho sentito colleghi proferire affermazioni del tipo ‘allora sarà VIETATO usare l’italiano’”. Davanti al compiacimento dell’abbandono dell’italiano il docente ha provato invano a replicare “se non suonasse letteralmente assurdo che potesse essere addirittura vietato usare l’italiano all’interno del territorio della Repubblica Italiana in un’istituzione di proprietà dello Stato Italiano finanziata tramite tasse versate dagli italiani la lingua ufficiale della Repubblica”; ma questo argomento suscita di solito un sollevamento di spalle.
#anglicismiNellItaliano #anglificazione #globalese #globalizzazione #globalizzazioneLinguistica #globish #inglese #interferenzaLinguistica #itanglese #linguaItaliana #paroleInglesiNellItaliano #plurilinguismo #università