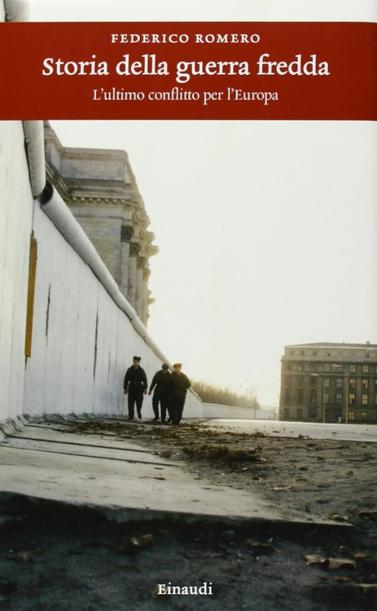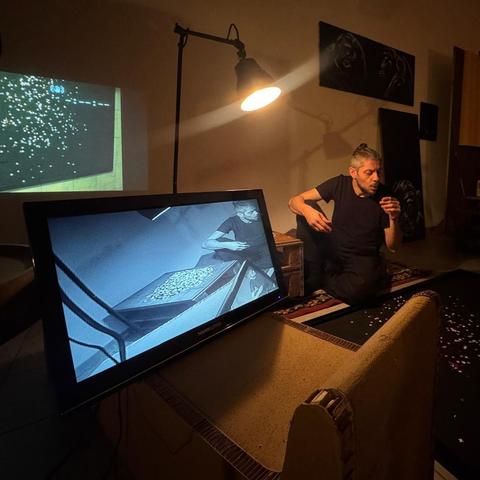La fine della guerra fredda
L’evento che più sconvolse gli equilibri internazionali alla fine degli anni Ottanta e che condizionò fortemente lo scenario politico italiano, dove il Partito comunista raccoglieva circa il 25-30 per cento dei consensi, fu la fine della Guerra Fredda. Tale scontro, pur non concretizzandosi mai in un vero e proprio conflitto militare, si consumò nel corso dei decenni attraverso vari campi, come quello aerospaziale, tecnologico, ideologico, sportivo, culturale e tecnologico-militare. Il termine “Guerra Fredda” fu coniato nel 1947 dal consigliere presidenziale americano Bernard Baruch e dal giornalista del New York Times, Walter Lippman, per descriverne l’emergere delle tensioni alla fine della Seconda guerra mondiale che aveva visto le due superpotenze alleate <1. Un contrasto, quello fra le due superpotenze, che mirava a presentare all’opinione pubblica internazionale il proprio modello di sviluppo come quello migliore in assoluto: il modello liberal-capitalistico americano da un lato, e quello comunista del blocco Sovietico dall’altro, dividendo così l’Europa Occidentale e Orientale attraverso la cortina di ferro e ideologicamente il mondo in due blocchi <2.
La politica di distensione ebbe inizio nel 1985 grazie al segretario del Partito comunista sovietico, Michail Gorbaciov, e al Presidente americano, Ronald Reagan. Il leader sovietico, infatti, aveva iniziato la sua carriera dopo la morte di Stalin avvenuta nel 1953, e quindi rappresentava l’ascesa al potere di una nuova classe politica desiderosa di cambiare la società russa e porre fine al totalitarismo e all’assenza di libertà. La situazione ereditata da Gorbaciov era grave: una crescita prossima allo zero e un drastico deprezzamento della moneta, dovuto soprattutto alla diminuzione del prezzo del petrolio, che costituiva il 60% delle esportazioni sovietiche <3. Ad aggravare ulteriormente il quadro vi era il fatto che l’URSS, sin dalla fine del secondo conflitto mondiale, aveva speso più del 25% del Prodotto Interno Lordo in armamenti, a discapito dei beni destinati alla popolazione, nell’obbiettivo di mantenere il ruolo di supremazia mondiale.
La politica di Gorbaciov ruotò attorno a due punti fondamentali: “glasnost”, una maggiore trasparenza nella vita pubblica russa che per anni era stata segnata dal totalitarismo staliniano; e “perestroika”, che indicava il complesso di riforme economiche con le quali si intendeva favorire una progressiva liberalizzazione del mercato sovietico. I primi importanti provvedimenti furono varati nel 1987. Le imprese statali furono riformate con l’obbiettivo di permettere loro di autofinanziarsi con i proventi delle vendite. Nello specifico, una volta che avessero ottemperato agli ordinativi dello Stato, queste erano libere di disporre del surplus merceologico a loro piacimento e di commercializzarlo a prezzo di mercato <4. Un’ulteriore rilevante riforma facente parte del complesso della perestroika fu la costituzione di una borsa merci a Mosca, che, a livello simbolico, rappresentò l’apertura dell’economia statalizzata verso il modello capitalista, introducendo per la prima volta la possibilità di movimento di capitali. Nel 1988 entrò in vigore <5 la nuova legge sui kolchoz, la proprietà agricola collettiva, che consentì la realizzazione di imprese commerciali o di produzione artigianale in forma privata, ripristinando di fatto la proprietà privata dei mezzi di produzione non strategici <6.
In virtù di una maggiore trasparenza vi fu una graduale liberazione dei dissidenti e un allentamento della censura, che diede inizio ad una progressiva libertà di stampa <7. Le conseguenze di queste politiche di rinnovamento furono distanti da quelle che Gorbaciov aveva prospettato <8. La legalizzazione del dissenso avrebbe auspicalmente dovuto portare a critiche costruttive sul sistema socio-economico sovietico: essa, invece, fu catalizzatore di voci e opinioni discordanti ma accomunate dall’obbiettivo di criticare severamente la leadership di Gorbaciov e le sue conseguenti scelte strategiche <9. Se una parte della burocrazia e della classe dirigente criticava le aperture all’Occidente, una fazione sempre più ampia di dissidenti non si accontentava solo di riformare il sistema ma individuava nell’abbattimento del comunismo il vero obbiettivo politico da perseguire <10.
I numerosi sprechi dovuti alle inefficienze della macchina statale che vennero via via propagati da un giornale all’altro, conseguentemente all’allentamento della censura, fornirono un lampante confronto fra il tenore di vita a Est e a Ovest della cortina di ferro, contribuendo a far aumentare ulteriormente il malcontento nei confronti del regime.
Furono soprattutto i paesi satellite dell’Europa dell’Est, dove il comunismo aveva sempre mostrato un volto tirannico e impopolare, il luogo dove si verificarono le conseguenze più immediate.
Il primo di questi paesi a capitolare, forte anche dell’appoggio cattolico garantito dell’allora pontefice Karol Wojtyla, fu la Polonia, dove operava già da diversi anni il sindacato indipendente denominato Solidarnosc, di ispirazione cattolica e apertamente ostile al comunismo. Avendo acquisito maggiori possibilità di movimento con l’ascesa di Gorbaciov, il sindacato polacco ottenne che vi fossero le prime elezioni libere in una delle due camere del Parlamento. Così, nel giugno del 1989, i polacchi furono chiamati alle urne, eleggendo in massa i candidati di Solidarnosc. Gli eventi polacchi innescarono <11 una reazione a catena.
Nel 1989, l’Ungheria decise di aprire la frontiera alla confinante Austria consentendo così, ai propri cittadini, di espatriare. Venne in tal modo abbattuta la lunghissima barriera di filo spinato lungo il confine che sanciva ufficialmente una breccia nella cortina di ferro che da decenni divideva l’Europa: da tutti i paesi del blocco sovietico, una volta raggiunta l’Ungheria e da lì entrando poi in Austria, sarebbe stato possibile muoversi liberamente nell’Europa occidentale <12.
Dal punto di vista diplomatico, i rapporti bilaterali fra URSS-Stati Uniti furono caratterizzati da un lento ma progressivo disgelo. Il primo passo del processo di distensione tra Reagan e Gorbaciov si tenne in Svizzera, a Ginevra, nel novembre del 1985. L’incontro segnò l’avvio di un dialogo fra le due potenze per ricostruirne le relazioni diplomatiche e segnò l’inizio del disarmo bilaterale che culminò due anni dopo con il trattato Intermediate Range Nuclear Forces Treaty che sanciva una riduzione del 50% dei missili nucleari installati da USA e URSS sul territorio europeo, i cosiddetti euromissili <13. Un processo e un’intesa che non saranno raggiunti senza difficoltà: l’insistenza di Reagan sulla sua Strategic Defense Iniziative, il programma missilistico progettato per abbattere testate nucleari nemiche nello spazio, non poteva non essere visto con sospetto dalla presidenza Gorbaciov che, quindi, premeva per un trattato che ne comprendesse la sua eliminazione ma che alla fine non sarà parte di alcun accordo: il presidente russo verrà a conoscenza del fatto che tale esperimento militare in realtà non aveva ancora le risorse tecnologiche ed economiche necessarie <14. Inoltre, nonostante gli accordi, la tensione tra i due blocchi rischiava ancora di rimanere molto alta a causa delle questioni ancora rimaste irrisolte sul versante della politica estera. Le due superpotenze si vedevano impegnate nel conflitto in Afghanistan e la situazione in Centro America minacciava il processo di distensione. Il conflitto in Afghanistan aveva avuto inizio nel 1979 con l’invasione delle armate rosse nel territorio, intenzionate a difendere il governo a orientamento socialista dai guerriglieri islamici che trovarono però l’appoggio logistico e un sostegno negli armamenti e nei rifornimenti da parte di nazioni come USA, Pakistan, Arabia Saudita, Regno Unito e Cina <15. A fronte delle ingenti perdite economiche che il conflitto aveva causato ai sovietici, e inoltre consapevoli dell’importante vantaggio logistico dei guerriglieri afghani, il giorno 20 luglio 1987 venne annunciato il ritiro delle truppe sovietiche dal territorio, di modo che il 14 Aprile dell’anno successivo, USA, Pakistan, Afghanistan e Urss firmarono a Ginevra un accordo per il suddetto ritiro delle truppe ma che avvenne solo nel 1989 <16. Ad aggiungersi a questo importante tassello verso la pace nei rapporti di forza tra America e Unione Sovietica, il 4 Marzo 1987, il presidente Reagan tenne il suo primo discorso alla nazione riguardo allo scandalo “Irangate”, che vedeva coinvolti alti funzionari e militari della sua amministrazione nel traffico illegale di armi con l’Iran su cui vigeva l’embargo. Il presidente americano ammise le sue responsabilità e quelle della sua amministrazione riguardo il traffico clandestino di armi ad alcune fazioni del regime di Khomeini, e l’appoggio al gruppo di guerriglieri Contras in Nicaragua che, negli anni tra il 1982 e il 1990 si opponevano al partito Sandinista di stampo marxista di Daniel Ortega <17.
L’anno che diede una definitiva svolta e che aprì ufficialmente il nuovo capitolo degli equilibri mondiali dalla Guerra Fredda, fu il 1989. Il 9 novembre, durante una delle grandi proteste che da mesi erano in corso in Germania dell’est contro il regime, il muro, che rappresentava il simbolo della separazione tra Est e Ovest, fu buttato giù dalla folla di manifestanti, sotto gli occhi della polizia che, a differenza di quanto era successo negli anni della cosiddetta cortina di ferro, non intervenne. Una data storica che verrà ricordata dalle generazioni successive come la data della “caduta del muro”. Uno ad uno, i paesi del patto di Varsavia andarono affrancandosi dall’influenza sovietica e abbandonarono le vecchie strutture comuniste: in Cecoslovacchia aveva inizio la rivoluzione di velluto con il rovesciamento del regime senza violenza, mentre in Romania questo risultato non si raggiunse se non con la dura repressione dell’esercito ai danni degli oppositori per ordine del presidente Nicolae Ceausescu, che non intendeva abbandonare il potere. Il dittatore rumeno fu catturato e giustiziato il 25 Dicembre 1989 <18.
Successivamente alla caduta del muro avevano inizio gli anni Novanta che avrebbero visto la dissoluzione definitiva dell’URSS. Il 28 giugno 1991 venne sciolto il Comecon, l’organizzazione economica che legava tra loro i paesi del blocco comunista e, tre giorni dopo, venne annullato il Patto di Varsavia. Il 21 dicembre dello stesso anno venne fondata la Comunità degli Stati indipendenti che riuniva Ucraina, Bielorussia e Russia: l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche cessava ufficialmente di esistere <19.
La fine della Guerra Fredda si apprestava così a propagare importanti ripercussioni sugli assetti politici dei paesi occidentali, regalando nuovo slancio alle istanze neoliberiste a discapito di politiche dirigiste e inevitabilmente accelerando le crisi identitarie di quei partiti che si definivano comunisti.
[NOTE]
1 J. Harper, La guerra fredda. Storia di un mondo in bilico, Il Mulino, Bologna, 2017.
2 J. Harper, La guerra fredda. Storia di un mondo in bilico, cit, pp.40.
3 R. Federico, Storia della guerra fredda: l’ultimo conflitto per l’Europa, Einaudi, Torino, 2009.
4 Ibidem.
5 V. Vidotto, G. Sabbatucci, Storia contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, Laterza, Bari, 2019.
6 R. Federico, Storia della guerra fredda: l’ultimo conflitto per l’Europa, cit, p.47.
7 V. Vidotto, G. Sabbatucci, Storia contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, cit, p.100.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 J. Harper, La guerra fredda. Storia di un mondo in bilico, cit, p.67.
11 V. Vidotto, G. Sabbatucci, Storia contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, cit, p.174.
12 R. Federico, Storia della guerra fredda: l’ultimo conflitto per l’Europa, cit, p.89.
13 V. Vidotto, G. Sabbatucci, Storia contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, cit, p.170.
14 R. Richard, Arsenals of Folly, Alfred A. Knopf, 2007.
15 V. Vidotto, G. Sabbatucci, Storia contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, cit, p.180.
16 J. Harper, La guerra fredda. Storia di un mondo in bilico, cit, p.244.
17 Ibidem.
18 V. Vidotto, G. Sabbatucci, Storia contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, cit, p.200.
19 V. Vidotto, G. Sabbatucci, Storia contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, cit, p.240.
Chiara Cavaliere, Tangentopoli: storia del declino economico e politico dell’Italia, Tesi di laurea, Università Luiss “Guido Carli”, Anno Accademico 2019-2020
#1985 #1987 #1989 #Berlino #caduta #Cecoslovacchia #ChiaraCavaliere #cortina #distensione #Europa #ferro #fine #fredda #glasnost #guerra #mercato #MichailGorbaciov #muro #Orientale #perestroika #Polonia #Romania #RonaldReagan #Ungheria #URSS #USA