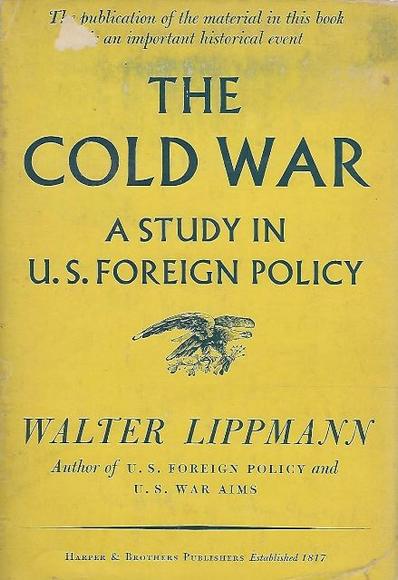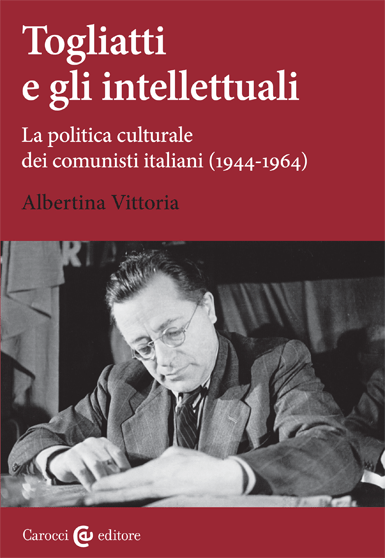Di fatto, cioè, la Guerra fredda fu una sfida per l’acquisizione del potere in tutte le sue forme da parte delle due superpotenze
Vista la mancanza di accordo tra studiosi ed esperti e considerate le nuove domande di cui si arricchisce, in generale, la storia internazionale <14, la storiografia sulla Guerra fredda è molto ampia e destinata, con buone probabilità, ad arricchirsi ulteriormente: come ha sottolineato Federico Romero, questa pluralità di punti di vista e di diverse prospettive rivela la difficoltà di individuare l’oggetto dello studio o, in altre parole, la difficoltà di definire quale sia la natura della Guerra fredda.
[…] Di fatto, cioè, la Guerra fredda fu una sfida per l’acquisizione del potere in tutte le sue forme da parte delle due superpotenze, fosse esso militare, politico, culturale, o economico. Nel corso del conflitto, le vittorie e le sconfitte su ognuno di questi ambiti furono misurate dall’avanzata o la ritirata dei due modelli, quello liberal-capitalista a trazione statunitense da una parte e quello socialista incarnato dall’Unione Sovietica dall’altro <16. La dimensione ideologica alla base delle scelte dei governi delle due superpotenze risulta fondamentale per spiegarne le motivazioni: è questo scontro, del resto, il vero fil rouge della Guerra fredda <17.
Come ha sottolineato Melvyn Leffler, la Guerra fredda fu sia il prodotto di un insieme di contingenze che delle ideologie che animavano i leader di Washington e Mosca, in parte frutto di pregiudizi e paure per la sicurezza nazionale e in parte della volontà di esportare il proprio modello politico ad altri stati <18. Sia gli Stati Uniti che l’Unione Sovietica, infatti, nutrivano la convinzione di incarnare le caratteristiche del modello politico migliore possibile, l’unico in grado di garantire la pace mondiale: per gli Stati Uniti, la mera esistenza di un paese con i caratteri dell’Unione Sovietica rappresentava la possibilità che si creassero nuovamente le condizioni per lo scoppio di una guerra mondiale. Finché fosse esistita l’URSS, pensavano le élite politiche statunitensi, il mondo non avrebbe potuto raggiungere una condizione di pace vera e duratura. Per l’Unione Sovietica, invece, il problema principale non era tanto quello annientare gli Stati Uniti in quanto tali, quanto quello di annichilire il loro progetto imperialista riconducendo la nazione alla condizione di “normalità” di uno stato borghese senza velleità espansionistiche <19.
In virtù di questa auto-rappresentazione e di questo modo di dipingere l’avversario, le classi dirigenti delle due nazioni credevano di essere investite di una missione universale: per gli Stati Uniti, il loro modello politico di stampo liberal-capitalista era l’unico in grado di funzionare e andava esportato nel resto del mondo. In modo uguale e contrario, la classe dirigente dell’Unione sovietica riteneva che le contraddizioni interne dei sistemi capitalistici li avrebbero condotti all’estinzione e all’inevitabile presa del potere delle classi proletarie, cosa che avrebbe a sua volta portato alla creazione di regimi comunisti in tutto il mondo. Si trattava di convinzioni radicate nella cultura nazionale e dettate da una lettura ideologica e pre-orientata dei fenomeni politici, oltre che di una diversa interpretazione del corso della storia <20.
Nel contesto della Guerra fredda, una definizione ristretta dell’ideologia non esaurisce le spiegazioni dietro alle singole scelte politiche dei governi statunitense e sovietico. In effetti, come suggerisce l’antropologo statunitense Clifford Geertz, con il termine “ideologia” si deve indicare qualcosa di più ampio rispetto a ciò che siamo più comunemente abituati a pensare. Secondo Geertz, l’ideologia non è una dottrina del pensiero con uno specifico e codificato riferimento scritto, come può essere il marxismo-leninismo ma, piuttosto, un «insieme di convinzioni connesse che riduce le complessità di una particolare porzione della realtà in termini facilmente comprensibili e suggerisce modi appropriati per confrontarsi con essa» <21. In questo senso, qualsiasi visione politica contiene in sé i tratti dell’ideologia, una serie di convinzioni pre-determinate, basate su elementi di irrazionalità o su giudizi acquisiti su una determinata questione. Per lungo tempo, gli uomini politici degli Stati Uniti hanno ritenuto di essere privi di condizionamenti ideologici e sbandierato la necessità di intraprendere una lotta contro i regimi politici che ne erano soggetti. Gli Stati Uniti non operavano sulla base dell’ideologia ma sulla base della sicurezza nazionale e della difesa dei valori democratici. In realtà, come ha messo in luce la storiografia statunitense dalla corrente revisionista in avanti <22, l’ideologia ha occupato un ruolo centrale nelle decisioni prese dalla classe politica statunitense, tanto in politica interna quanto, forse in modo più evidente, in politica estera. L’eccezionalismo, l’idea dell’esistenza di una “gerarchia delle razze”, l’anti-radicalismo, rappresentano, così, i tasselli di un paradigma ben consolidato sulla base del quale sono state adottate numerose scelte politiche che non si possono spiegare in termini di mera convenienza materiale o di analisi realiste degli equilibri di potere <23.
Il rapporto tra politica ed ideologia nel conflitto tra Stati Uniti e Unione Sovietica fu messo in luce dal giornalista Walter Lippmann, che parlò per la prima volta di «Guerra fredda» in una raccolta di saggi pubblicata nel 1947 <24 in risposta al famoso saggio pubblicato da George Kennan in forma anonima su “Foreign Affairs”, la rivista del Council on Foreign Relations, nel 1947. Kennan, che lanciava così la dottrina del containment, scrisse che: “[…] The thoughtful observer of Russian-American relations will find no cause for complaint in the Kremlin’s challenge to American society. He will rather experience a certain gratitude to a Providence which, by providing the American people with this implacable challenge, has made their entire security as a nation depending on their pulling themselves together and accepting the responsibilities of moral and political leadership that history plainly intended them to bear” <25.
Le parole del diplomatico statunitense erano rivolte al pubblico di “Foreign Affairs”, fatto di specialisti e politici, ed erano destinate ad avviare un intenso dibattito sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo dopo la fine della Seconda guerra mondiale. I decisori politici sotto l’amministrazione del presidente Truman sposarono le convinzioni di Kennan e ne fecero la base per la loro strategia nei confronti dell’Unione Sovietica. L’immagine del nemico si arricchì, nel tempo, di particolari preoccupanti per gli Stati Uniti. Nel 1950, Truman commissionò un documento al Policy Planning Staff del National Security Council che contenesse informazioni sulla politica sovietica (conosciuto come l’NSC 68). Il risultato fu un report dai toni quasi propagandistici, benché riservato esclusivamente all’uso interno del governo: «L’obiettivo del Cremlino […]», scrissero gli esperti del governo federale guidati da Paul Nitze, «è la sottomissione totale dei popoli sotto il suo controllo […]. La politica del Cremlino verso le aree che non sono sotto il suo controllo è l’eliminazione della resistenza al suo volere e l’estensione della sua influenza e controllo. Persegue questa politica perché non può […] tollerare l’esistenza di società libere» <26. Sulla base di una lettura così allarmante per il futuro degli Stati Uniti, la classe dirigente americana decise di mettere in campo tutti gli strumenti utili a spostare in proprio favore gli equilibri internazionali. Le armi e la diplomazia non sarebbero più stati sufficienti a questo sforzo; bisognava sconfiggere i sovietici anche sul piano dell’immaginario collettivo, conquistando “i cuori e le menti” dell’opinione pubblica mondiale.
[NOTE]
14 Thomas Zeiler, The Diplomatic History Bandwagon: A State of the Field, in “The Journal of American History”, Vol. 95, No. 4, 2009, pp. 1053-1073 e le risposte di Mario Del Pero, On the Limits of Thomas Zeiler’s Historiographical Triumphalism, in “The Journal of American History”, Vol. 95, No. 4, 2009, pp. 1079-1082 e Jessica Gienow-Hecht, What Bandwagon? Diplomatic History Today, in “The Journal of American History”, Vol. 95, No. 4, 2009, pp. 1083-1086.
16 Nigel Gould Davis citato in Giles Scott-Smith, Western Anti-Communism and the Interdoc Network. Cold War Internationale, London, Palgrave Macmillan, 2012, p. 2.
17 Si veda la riflessione di Leopoldo Nuti, On recule pour mieux sauter, or “What needs to be done” (to understand the 1970s), in Pons and Romero (edited by), Reinterpreting the End of the Cold War., cit., pp. 39-51.
18 Cfr. Melvyn P. Leffler, For the Soul of Mankind: the United States, the Soviet Union and the Cold War, New York, Hill and Wang, 2007.
19 Stephanson, Fourteen Notes, cit.
20 Westad, The Global Cold War, cit., p. 40.
21 Clifford Geertz citato in Michael H. Hunt, Ideology, in Frank Costigliola and Michael J. Hogan (edited by), Explaining the History of American Foreign Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 222.
22 L’inizio della corrente storiografica revisionista è attribuito a William A. Williams, The Tragedy of American Diplomacy, New York, Dell Publishing Co., 1962. Cfr. anche Anthony Mohlo and Gordon S. Wood (edited by), Imagined Histories. American Historians Interpret the Past, Princeton, Princeton University Press, 1998, Frank Ninkovich, The Wilsonian Century. American Foreign Policy since 1900, Chicago and London, University of Chicago Press, 1999 e Erez Manela, The Wilsonian Moment. Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism, Oxford, Oxford University Press, 2007; Gordon S. Wood, Empire of Liberty: A History of the Early Republic, 1789-1815, Oxford, Oxford University Press, 2009.
23 Cfr. Michael H. Hunt, Ideology and U.S. Foreign Policy, New Haven and London, Yale University Press, 1987.
24 Walter Lippmann, The Cold War: a Study in U.S. Foreign Policy, New York, Harper, 1947.
25 X, The Sources of Soviet Conduct, in “Foreign Affairs”, Vol. 25, No. 4, Jul., 1947, p. 582.
26 Ibidem.
Alice Ciulla, Gli intellettuali statunitensi e la “questione comunista” in Italia, 1964-1980, Tesi di dottorato, Università degli Studi Roma Tre, 2012
#1947 #AliceCiulla #anticomunismo #autoRappresentazione #CliffordGeertz #FedericoRomero #fredda #GeorgeKennan #guerra #ideologie #MelvynLeffler #pace #PaulNitze #storiografia #superpotenze #URSS #USA #WalterLippmann