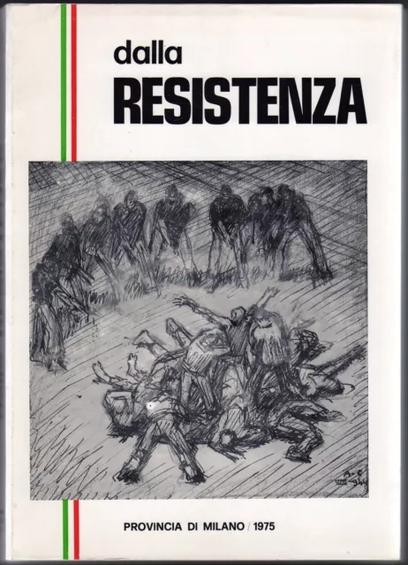Gioia e Rivoluzione… 033 – La bomba di Haymarket a Chicago 1886 https://radiowombat.net/gioia-e-rivoluzione-033-la-bomba-di-haymarket-a-chicago-1886/ #gioiaerivoluzione...maanchesconfitte #gioiaerivoluzione #Haymarket #anarchia #1maggio #chicago #martiri #rivolta #tumulto #operai #moti #usa
#Operai
Buon #PrimoMaggio!
Celebriamo la #FestaDeiLavoratori vivi e morti in un paese con
istituzioni indifferenti alla strage di #operai
e una classe imprenditoriale con punte di criminalità che ignora le misure di sicurezza per indifferenza alla vita umana o per produrre di più
Operai está arreglando un 'error' que permitió a los menores suscitar conversaciones eróticas #arreglando #conversaciones #eróticas #error #está #generar #los #menores #OpenAI #Operai #permitió #ButterWord #Spanish_News Comenta tu opinión 👇
https://butterword.com/operai-esta-arreglando-un-error-que-permitio-a-los-menores-suscitar-conversaciones-eroticas/?feed_id=19532&_unique_id=681015c1f2b3d
¿Por qué Operai quería comprar cursor pero optó por el Windsurf de rápido crecimiento? #comprar #Crecimiento #cursor #EXCLUSIVO #fusiones_y_adquisiciones #OpenAI #Operai #optó #pero #por #Qué #quería #rápido #windsurf #ButterWord #Spanish_News Comenta tu opinión 👇
https://butterword.com/por-que-operai-queria-comprar-cursor-pero-opto-por-el-windsurf-de-rapido-crecimiento/?feed_id=18706&_unique_id=68082a085eebc
Operai ha publicado su primera investigación sobre cómo el uso de chatgpt afecta el bienestar emocional de las personas #afecta #bienestar #ChatGPT #como #emocional #investigación #Las #Operai #personas #Primera #publicado #sobre #uso #ButterWord #Spanish_News Comenta tu opinión 👇
https://butterword.com/operai-ha-publicado-su-primera-investigacion-sobre-como-el-uso-de-chatgpt-afecta-el-bienestar-emocional-de-las-personas/?feed_id=13331&_unique_id=67e08ec01d2c2
El soneto de Claude 3.7 de Anthrope apunta a Operai y Deepseek en la próxima gran batalla de AI #Anthrope #apunta #batalla #Claude #Deepseek #gran #Operai #próxima #soneto #ButterWord #Spanish_News Comenta tu opinión 👇
https://butterword.com/el-soneto-de-claude-3-7-de-anthrope-apunta-a-operai-y-deepseek-en-la-proxima-gran-batalla-de-ai/?feed_id=8262&_unique_id=67bce8df3a268
“diario di fabbrica”, di rosamaria vaccaro
Tutta Scena Teatro ★ Radio Onda Rossa 87.9 fm
http://archive.org/details/Radioteatro.DiarioDiFabbrica
liberamente ispirato a La condizione operaia di Simone Weil
drammaturgia di Rosamaria Vaccaro
con Ermelinda Bonifacio
musiche di Alessandro Sgarito
«Quando ci si mette davanti alla macchina bisogna uccidere la propria anima per 8 ore al giorno, i propri pensieri, i sentimenti, tutto. Irritati tristi o disgustati che si sia, bisogna inghiottire» (Simone Weil, La condizione operaia).
Rosamaria Vaccaro si dedica al periodo biografico di prima rottura col quotidiano e racconta Simone Weil ricostruendo una giornata di lavoro in fabbrica. Una sorta di diario in cui si possono leggere le sue considerazioni, tuttora attuali, sul lavoro e sui lavoratori; percorrere i rapporti di solidarietà che la filosofa intesse con gli operai e quelli talvolta difficili con il caporeparto; osservare il complesso rapporto con il macchinario. Fondante la tematica del potere e della subalternità, in questo lavoro emerge un’umanità ricca e variegata, palpabile e vicina. La stessa umanità analizzata da James Taylor ed Henry Ford che Weil sceglie di incontrare, mescolandosi ad essa sino a confondersi e perdersi.
http://archive.org/details/Radioteatro.DiarioDiFabbrica (30’)
info http://csalatorre.net/2012/03/diario-di-fabbrica/
#AlessandroSgarito #diario #DiarioDiFabbrica #ErmelindaBonifacio #fabbrica #HenryFord #JamesTaylor #LaCondizioneOperaia #operai #RadioOndaRossa #ROR #RORRadioOndaRossa #RosamariaVaccaro #SimoneWeil #TuttaScenaTeatro
VIDEO | Vertenza #Beko, usa la #pensione per aiutare gli #operai http://www.youtube.com/watch?v=7lSdLW_2RpU&pp=ygUJSWRhIEJvenpp https://www.larampa.news/2025/02/vertenza-beko-usa-pensione-aiutare-operai/
settanta (di un secolo qualsiasi) / giancarlo busso
“L’angoscia è una stanza grande, ampia, col pavimento di legno
rialzato sopra il suolo […] Tutto può entrare:
Venti di nubi, fantasmi,
Tutto può anche uscire, come in un vento…”
Carlo Bordini, Titolo ignoto
. parlavano nello stanzone 168 operai trapassati, sapevano a chi toccava. il fiume Stura
era pieno di acido, prima i pesci. non si può credere, non può essere successo.
i pioppi lungo la strada di campagna cambiavano le foglie per liberarsi dal male, i topi
correvano, morivano senza zampe, fuse con il pavimento, non più carne. giovani operai
di vent’anni, figli di altri, morivano a quaranta urinando sangue.
non si può credere, non può essere successo. avevi dato giustizia in tribunale, le prime
condanne di un paese simile a ciò che non vogliamo. i morti tornavano alle tombe corrose,
le bare scoppiate, le lenzuola macchiate di ammine aromatiche, le sindoni della fabbrica di colori
ritrovate in fosfeni di archivi digitali,
Tuoi testimoni nel disordine della memoria.
NAPOLI: OPERAI GLS PRIMA LICENZIATI, POI CARICATI E SGOMBERATI DALLA POLIZIA. LA CONFERENZA STAMPA DI DENUNCIA https://www.radiondadurto.org/2025/01/31/napoli-operai-gls-licenziati-caricati-e-sgomberati-dalla-polizia-la-conferenza-stampa-di-denuncia/ #picchetto #sciopero #sgombero #cariche #polizia #Lavoro #napoli #operai #News #gls
#GiornoDellaMemoria L'A.N.P.I. di Cinisello Balsamo ha realizzato questa mostra sui luoghi e le storie della deportazione: https://anpicinisello.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/01/anpi-mostra-deportati-2025-a4.pdf La mostra, che oggi era nella piazza principale di #Cinisello, ha già girato e continuerà a girare nelle scuole superiori della zona #storia #memoria #antifascismo #ANPI #ScioperiMarzo1944 #operai @scuola@a.gup.pe @scuola@mastodon.uno @mcp @
@wikimediaitalia
@lindasartini
026 – Gioia e rivoluzione… Rivolta Corso Traiano 1969 https://radiowombat.net/026-gioia-e-rivoluzione-rivolta-corso-traiano-1969/ #gioiaerivoluzione...maanchesconfitte #gioiaerivoluzione #autonomiaoperaia #corsoTraiano #rivolta #operai #torino #Italy #1969 #casa #FIAT
BRESCIA: MIGLIAIA DI PERSONE IN CASSA INTEGRAZIONE NEL SETTORE METALMECCANICO https://www.radiondadurto.org/2024/12/24/brescia-migliaia-di-persone-in-cassa-integrazione-nel-settore-metalmeccanico/ #NAZIONALI #stanadyne #stanadye #brescia #operai #iveco #News #FIOM
La reindustrializzazione della ex Gkn è più vicina. “Adesso va fatto il consorzio” https://altreconomia.it/la-reindustrializzazione-della-ex-gkn-e-piu-vicina-adesso-va-fatto-il-consorzio/ #delocalizzazione #campibisenzio #speculazione #lavoratori #Attualità #Firenze #toscana #operai #gff #GKN
La mia solidarietà alle famiglie dei 3 #operai morti sul lavoro ieri, nella continua, colpevole indifferenza e inazione delle istituzioni della Repubblica Italiana
https://youtu.be/XnuwSfKluxc?si=FRHx0NHOf4j4PS8F
Anni ’70. Frammenti rivoluzionari
a cura di Giuseppe Garrera
24 ott. 2024
Goethe Institut, Roma
#anarchia #Anni70 #anniSettanta #CarlaLonzi #comunismo #controIlLavoro #fabbrica #femminismo #frammenti #frammentiRivoluzionari #GoetheInstitut #lottaArmata #NanniBalestrini #operai #RivoltaFemminile #VogliamoTutto
C’era un numero di partigiani limitato per un’area vasta come la Brianza
Un ambiente privilegiato per la diffusione dell’antifascismo è, quanto meno a Monza e nella bassa Brianza, la grande fabbrica fordista. Monza si trova a ridosso delle grandi fabbriche di Sesto San Giovanni e di Milano (Breda, Falck, Innocenti, Magneti Marelli, Pirelli…). Tra le masse operaie delle grandi aziende milanesi “il partito comunista era penetrato in profondità, aveva fatto proselitismo e le teorie antifasciste associate a quelle di lotta di classe avevano preso piede. Queste idee venivano poi irradiate verso la provincia dagli operai brianzoli che vi lavoravano e dagli sfollati che dopo i tremendi bombardamenti dell’agosto 1943 su Milano si dirigevano sempre più numerosi verso la provincia” <26. La creazione di gruppi antifascisti che derivano dall’antifascismo delle fabbriche, dove erano già presenti cellule clandestine, si registrano ad Agrate Brianza, Cavenago Brianza, Lissone e Seregno <27. Nei paesi più lontani dal milanese e da Monza la struttura economica è caratterizzata da piccole aziende dove il PCI i partiti di sinistra non hanno ancora radicamento e, anche se la popolazione in larga parte è avversa al fascismo repubblicano e all’invasore tedesco, manca, specie nei primi mesi successivi all’armistizio, un’organizzazione antifascista strutturata, che tarderà a vedere la luce <28. Emerge quindi uno scenario duplice, cioè un contesto, quello della Bassa Brianza, influenzato dall’antifascismo diffuso tra il proletariato delle grandi fabbriche e il resto del circondario monzese, specie le aree più distanti da Milano, in cui, in particolare nei primi mesi della Resistenza, non è ancora presente un’organizzazione partigiana consolidata e l’elemento spontaneistico prevale.
In Brianza l’attività predominante consiste nell’assistenza logistica ai partigiani riparati sui monti e, specie nella prima fase resistenziale, non vi è una vera e propria lotta armata contro i nazifascisti <29.
I Gap (Gruppi d’azione patriottica), cioè i nuclei partigiani organizzati dal PCI per il combattimento in città, sono le uniche formazioni che nei primi mesi di occupazione tedesca svolgono attività di tipo terroristico per creare insicurezza tra i nazifascisti. In Brianza non sono presenti i Gap, ma si registrano alcune azioni armate di gappisti giunti da Milano <30. Il principale obiettivo dei Gap in territorio monzese è Luigi Gatti, squadrista di vecchia data, dirigente dell’UPI e maggiore della GNR presso la Villa Reale di Monza dove tortura gli oppositori arrestati. Il 20 ottobre 1943 due gappisti, operai milanesi, sparano al Gatti, che però risulta solo ferito. Subito dopo l’attentato la reazione fascista si concentra sui noti antifascisti locali, dieci dei quali vengono immediatamente arrestati e ne viene decretata la fucilazione per rappresaglia. Anche grazie al fatto che le ferite del Gatti non sono particolarmente gravi, hanno successo le pressioni del medico curante dottor Arrigoni e dell’Arciprete perché lo stesso Gatti si pronunci contro la rappresaglia: così avviene e la condanna a morte viene revocata <31.
I CLN
Un ruolo determinante nella guida della Resistenza italiana sono stati i Comitati di Liberazione Nazionale (Cln), cioè i comitati costituiti dai partiti antifascisti (DC, PCI, Pd’A, PLI, PSIUP). Già l’8 settembre il comitato romano assume tale nome. Il riferimento dei liberali nel comitato romano è “Alessandro Casati, appartenente ad un’antica famiglia nobiliare che risiedeva ad Arcore” <32, in Brianza. Il Cln di Milano si costituisce anch’esso nel corso del settembre 1943 e ha tra i suoi membri anche i monzesi Giovanbattista Stucchi (socialista) e Gianni Citterio (comunista). Nel gennaio 1944 il Cln di Milano è investito da quelli del settentrione del ruolo di organismo guida della ribellione nel nord-Italia. Il comitato romano, prevedendo una rapida liberazione della Capitale da parte degli Alleati, approva tale investitura: nasce così il Clnai (Comitato di liberazione nazionale alta Italia). A Monza, i rappresentanti del comitato sono coloro hanno fondato nel 1942 il già citato Fronte d’azione antifascista e, cioè, Fortunato Scali per i comunisti, Enrico Farè per i socialisti e Luigi Fossati per i democristiani <33. I primi Cln in territorio brianzolo scontano numerosi arresti e continue sostituzioni in quanto si trovano isolati tra di loro e le forze partigiane sono ancora scarse: occorrerà del tempo perché la struttura organizzativa del movimento partigiano si sviluppi nella Brianza monzese <34.
Un punto di svolta nella fase resistenziale sono stati i grandi scioperi operai del marzo 1944, che coinvolgono anche la Brianza. Il grande sciopero del marzo 1944, al contrario agli scioperi del 1943, non pone al centro le rivendicazioni economica, ma è, bensì, un’iniziativa politica del Partito comunista: l’obiettivo dello sciopero è quello di dare una prova di forza politica dell’opposizione al fascismo e all’occupazione tedesca <35.
“Il primo marzo scatta la contestazione in tutte le città del nord. Nel milanese, l’area di Sesto San Giovanni è determinante: la Breda, la Falck, la Magneti Marelli sono il fulcro dello sciopero e il punto di riferimento, naturalmente anche per la Brianza” <36. Lo sciopero riguarda anche il territorio brianzolo, soprattutto l’area di Monza, in cui si trovano importanti aziende industriali. Lo sciopero riguarda molte aziende monzesi, come la Hensemberger, la Singer, dove rientra rapidamente a causa della minaccia nazista, la Philips e la Sertum. Altre realtà industriali brianzole coinvolte sono la Bianchi di Desio e la Isotta Fraschini di Meda. Il secondo giorno di sciopero il Rapporto sullo sciopero generale del 1 marzo a Milano e provincia, redatto dal PCI, informa “che a Monza a causa della brutalità della reazione in alcuni stabilimenti il lavoro è stato ripreso” <37. Infatti, mentre a Milano e Sesto San Giovanni lo sciopero si protrae fino all’8 marzo, nel monzese lo sciopero non dura oltre i due giorni. Ad ogni modo la partecipazione allo sciopero non può dirsi negativa per una terra come la Brianza dove “gli scioperanti non potevano contare, al contrario di Sesto San Giovanni, sulla forza di enormi masse che lavorano nelle grandi fabbriche di città industriali; la repressione poteva avere buon gioco e gli agitatori potevano essere più facilmente individuati” <38. Agli scioperi seguono numerosi arresti e deportazioni nei lager tedeschi. Il PCI si rende conto che le squadre di difesa delle fabbriche, create su sua iniziativa a inizio 1944, non sono in grado di reggere l’onda d’urto della reazione nazifascista <39. Emerge quindi la necessità di un ripensamento organizzativo che porta alla nascita delle Sap.
Le SAP
Nell’estate del 1944 nascono le Sap (Squadre armate partigiane) per idea del comunista Italo Busetto <40. Le squadre delle Sap sono costituite nelle città da cinque uomini e, cioè, un caposquadra e quattro partigiani, mentre nei paesi il caposquadra, scelto nella figura più carismatica del gruppo, coordina tre gruppi composti da cinque uomini l’uno. Le squadre si raggruppano in distaccamenti idealmente di 45-50 uomini; cinque o sei distaccamenti costituiscono una brigata. Il partigiano delle Sap, al contrario dei Gappisti che vivono in clandestinità, se non è un renitente o un ricercato, vive nella legalità, svolgendo il proprio lavoro ed entrando in azione quando è chiamato a farlo <41.
Le Sap, pur essendo una formazione di emanazione del Partito Comunista, “assumono più un aspetto di milizia nazionale, contando nei propri ranghi elementi delle più disparate tendenze politiche” <42.
L’organizzazione delle Sap nella Brianza monzese si articola nell’estate del 1944 come segue <43 <44:
1° settore di Oggiono, poi rientrerà nella 104^ brigata Gianni Citterio. Comandante: Livio Cesana. Distaccamenti: Oggiono, Carate Brianza, Macherio, Biassono, Costamasnaga, Renate. Totale: 177 uomini.
2° settore di Monza, poi 150° brigata. Comandante: Moretto. Distaccamenti: Monza e Vedano al Lambro. Totale: 22 uomini.
3° settore di Vimercate. Comandante prima compagnia, che successivamente si dividerà tra 104° brigata Gianni Citterio e 103° brigata Sap Vincenzo Gabellini <45, Iginio Rota. Distaccamenti: Vimercate, Arcore, Bernareggio, Bellusco, Concorezzo, Cavenago. Totale: 140 uomini.
La seconda compagnia è dislocata a Trezzo d’Adda e dintorni. La terza compagnia (poi 105^ brigata Luigi Brambilla, è composta dai distaccamenti di Brugherio, Caponago, Agrate Brianza, Bussero, Cascine S. Ambrogio, Cernusco sul Naviglio, Carugate. Totale: 159 uomini.
Si costituisce anche una 3^ brigata Sap nella zona tra Saronno (Varese) e la Brianza monzese. Per quest’ultima area si registrano a Meda 40 sappisti attivi dai distaccamenti dell’Isotta Franchini, 12 dall’azienda F.A.C.E., oltre che 36 partigiani delle Sap a Cesano Maderno, 25 a Meda città, 5 a Paderno Dugnano, 150 nell’area compresa tra Bovisio, Varedo, Villaggio Snia, Seveso e Ceriano Laghetto <46.
A fine del 1944 le file delle Sap si ingrossano: si sono via via costituite nuove brigate che confluiranno nel Raggruppamento brigate Bassa Brianza. Tale raggruppamento, guidato dal comandante Eliseo Galliani e dal commissario politico Eugenio Mascetti, riunisce a sé la 119^ brigata Quintino Di Vona con distaccamenti a Nova Milanese, Muggiò, Lissone, Desio, Seregno, Carate Brianza, Paina, Arosio, Inverigo, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Bresso e Cormano Brusuglio e la 185^ brigata Pietro Arienti con distaccamenti a Cesano Maderno, Bovisio, Seveso, Meda, Barlassina, Paderno Dugnano, Palazzolo, Senago e Limbiate. Rientrano nel raggruppamento anche i distaccamenti per la difesa interna delle industrie quali la Snia e Acna di Cesano Maderno, la Isotta Franchini di Meda e la Bianchi di Desio <47.
Contestualmente le Brigate Garibaldi sono riorganizzate anche nella parte orientale della Brianza, con il Raggruppamento brigate fiume Adda. Confluiscono in tale raggruppamento la 103^ brigata Vincenzo Gabellini con distaccamenti a Vimercate, Bernareggio, Cavenago, Mezzago e Trezzo d’Adda, la 104^ brigata Gianni Citterio e la 105^ brigata Luigi Brambilla con distaccamenti in Brianza a Caponago e Brugherio <48.
Le brigate garibaldine si sono quindi costituite anche in Brianza, sebbene, specie nei primi tempi, la struttura organizzativa sia ancora gracile e il numero dei partigiani limitato per un’area vasta come la Brianza, tanto che non di rado risultano difficili i collegamenti con le altre brigate e il comando. Nonostante le difficoltà, le Sap si rafforzano progressivamente cosicché anche la lotta contro i fascisti e i tedeschi ne trae beneficio in termini di aumento degli attacchi armati sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo <49.
Nel corso del 1944, e in particolare durante l’estate, sono creati i Cln nel territorio brianzolo. Se in un primo momento esisteva solo il Cln di Monza, nel corso dell’estate un po’ in tutti i paesi si formano i Cln. Così facendo la Resistenza prende piede nella maggior parte dei comuni della Brianza. L’operatività e, soprattutto, l’attitudine alla lotta partigiana, dei Cln è però disomogenea: vi sono, ad esempio, alcuni Cln locali del tutto passivi, improntati più a frenare la ribellione invece che ad alimentarla. Alcuni problemi, legati all’inesperienza dei partigiani, alla presenza massiccia di forze nemiche nella zona o alla difficoltà dei collegamenti, pur migliorando nel tempo, permangono fino alla Liberazione. Tuttavia, l’aspetto più significativo che si può desumere dalle biografie dei componenti dei Cln locali è l’inedita partecipazione alla vita politica e sociale degli appartenenti di tutte le classi sociali <50 <51.
[NOTE]
26 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 52.
27 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 53.
28 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 54.
29 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 54.
30 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 54.
31 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 54.
32 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 55.
33 G. Bianchi, Dalla Resistenza. Uomini, eventi, idee della lotta di Liberazione in provincia di Milano, edizione della Provincia di Milano, Milano, 1975, pag. 27.
34 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 56.
35 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 60.
36 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 60.
37 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 60.
38 Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso, L’archivio Basso e l’organizzazione del partito (1943-1945), vol. 8, 1985, 1986, pag. 400, “Ditte con più di 500 dipendenti”.
39 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 97.
40 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 97.
41 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 97.
42 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 99.
43 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 100.
44 G. Bianchi, Dalla Resistenza. Uomini, eventi, idee della lotta di Liberazione in provincia di Milano, edizione della Provincia di Milano, Milano, 1975, pag. 30-31.
45 G. Bianchi, Dalla Resistenza. Uomini, eventi, idee della lotta di Liberazione in provincia di Milano, edizione della Provincia di Milano, Milano, 1975, pag. 33.
46 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 100.
47 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 137.
48 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 138.
49 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 100.
50 P. Arienti, La Resistenza in Brianza 1943-1945, Bellavite, Missaglia (LC), 2006, pag. 106.
51 G. Bianchi, Dalla Resistenza. Uomini, eventi, idee della lotta di Liberazione in provincia di Milano, edizione della Provincia di Milano, Milano, 1975, pag. 30.
Enrico Comini, La Corte di Assise Straordinaria di Monza. I processi per collaborazionismo a Monza (1945-1946), Tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 2022-2023
#1943 #1944 #Arosio #Barlassina #Bovisio #Brianza #CarateBrianza #CesanoMaderno #CiniselloBalsamo #CLN #comunisti #CusanoMilanino #Desio #EnricoComini #fabbriche #fascisti #GAP #GNR #Inverigo #Lissone #marzo #Meda #Milano #Monza #Muggiò #NovaMilanese #operai #PadernoDugnano #Paina #Palazzolo #partigiani #SAP #scioperi #Seregno #Seveso #tedeschi
la mia solidarietà va alla classe #operaia distrutta dalle politiche socialmente criminali del governo che ha eliminato il #RedditoDiCittadinanza, unico argine alla povertà assoluta, e che è indifferente alla strage di #operai sul lavoro
L'EDITORIALE | #Giornalisti e #operai uniti nella lotta contro #JohnElkann
https://www.larampa.news/2024/09/giornalisti-operai-uniti-lotta-contro-john-elkann/
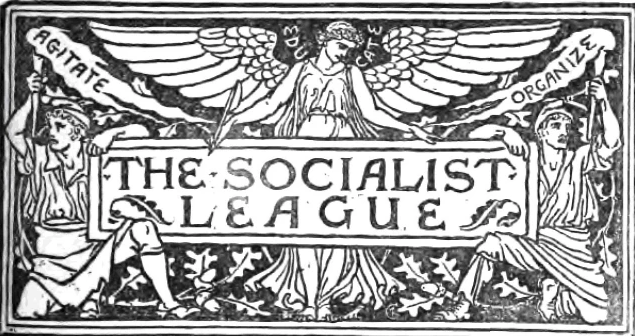

![I lavoratori delle fabbriche di Sesto San Giovanni
[...]
Il comandante della Guardia Nazionale Repubblicana della zona scriveva al Comando provinciale a proposito di Sesto san Giovanni: “[...] è una vera maledizione questo centro industriale totalmente sovversivo. Lì sta veramente il cancro della Lombardia. Questa città rossa dovrebbe essere completamente distrutta al
di fuori delle industrie con il sistema germanico. La popolazione maschile deportata in Germania”.](https://files.mastodon.social/cache/media_attachments/files/113/895/647/786/822/754/small/6b8feddfdc00e171.png)