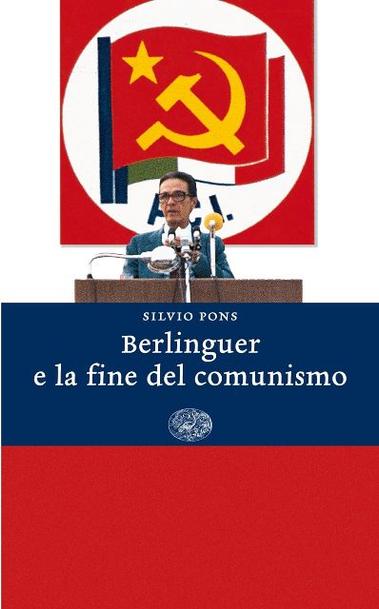🕸glané sur le net🕸 Enrico Berlinguer et le rêve brisé: « Berlinguer. La grande ambition »… Le film d'Andrea Segre raconte cinq années de la vie d'Enrico Berlinguer, secrétaire général du PC italien entre 1973 et 1978, entre… #EnricoBerlinguer #FilmPolitique #HistoireItalienne #AndreaSegre
Enrico Berlinguer et le rêve b...
#enricoberlinguer
Il 1976 si rivela essere un anno cruciale per il PCI
La seconda metà degli anni ’70 ha acuito le difficoltà che l’Italia stava affrontando già dal decennio precedente: proprio per questo, l’ingresso del PCI nell’area di governo appare in modo più realistico come una necessità. Dal 1968 il PCI aveva cominciato a crescere a un ritmo importante nelle elezioni, e nel 1975 ottiene un ulteriore successo nelle elezioni amministrative. In particolare, con un grande aumento nelle regioni del Nord, il PCI salì dal 27,9% al 33,4% e la DC scese al 35,3%: con soli due punti di differenza, tuttavia, il PCI non avanzò richieste di governo poiché la situazione internazionale e la distensione erano ancora a rischio. <68
Berlinguer e il suo partito cercano quindi di incrementare le relazioni positive con gli altri partiti democratici nazionali ed europei, in particolare con le socialdemocrazie. Ormai, la questione comunista in Europa coincideva con il comunismo in Italia, al quale il mondo guardava con attenzione crescente. È chiaro che una responsabilità di governo in capo a un Partito comunista in un Paese NATO avrebbe significato un enorme cambiamento sul piano distensivo, e le due superpotenze avrebbero dovuto prendere in considerazione una modifica della strategia dei due blocchi contrapposti, che avrebbe anche potuto significare una dissoluzione degli stessi. <69 Stando al parere dei comunisti italiani, e in particolare del più stretto collaboratore di Berlinguer Antonio Tatò, un’apertura governativa al PCI avrebbe potuto guidare i Paesi del “socialismo reale” verso una spinta riformista e una maggiore accettazione dei valori di libertà. In realtà, anche all’interno del Partito comunista italiano si delineavano due diverse tendenze: da una parte, i realisti concepivano gli orientamenti nazionali internazionali come svincolati da principi diversi da quello dell’interesse di partito; la tendenza che invece difendeva l’identità poneva maggiore enfasi sulla missione egemonica del comunismo che puntava al rinnovamento della politica. <70 Berlinguer, tra queste due, teneva una posizione “centrista”, senza lasciare indietro l’identità del partito ma rivolta al realismo politico, infatti il percorso che stava tracciando con la collaborazione nel governo lasciava intravedere una maggiore garanzia dei rapporti con l’alleanza occidentale.
Una prima possibilità di cambiamento nella politica italiana si apre quando, nel 1976, viene eletto il democratico Jimmy Carter alla Presidenza degli Stati Uniti. In realtà, a livello nazionale il cambiamento era già in corso con il governo Moro-La Malfa che, sostenuto da DC, PRI, PSI e PSDI, collaborava volentieri con il PCI perseguendo insieme la strada delle riforme, mentre l’incapacità della destra di allontanarsi dalla tradizione fascista la escluse a priori dalle responsabilità di governo. Tra questi, il partito che più di tutti faticava ad accettare il coinvolgimento dei comunisti era il PSI di De Martino, che aprì il 1976 dando le proprie dimissioni e creando, quindi, una crisi di governo. De Martino aveva difficoltà nel fare parte di un governo che dialogava più volentieri con il PCI piuttosto che con il PSI, e con il quale erano state introdotte importanti novità come il voto ai diciottenni e la riforma carceraria, su spinta proprio del PCI. Il PSI stava perdendo il ruolo di “cerniera” che lo aveva caratterizzato nel mantenere un dialogo tra la sinistra extra governativa e i partiti di governo. <71
Il ’76 si rivela essere un anno cruciale per il PCI, che proseguì sulla strada dell’istituzionalizzazione con l’assegnazione della Presidenza della Camera dei deputati al comunista Pietro Ingrao. Oltre a ruoli istituzionali, alle elezioni politiche del 1976 il PCI raggiunse il 34,4% dei voti, percentuale che segnerà il suo massimo storico. Il successo elettorale coincise con la crescita del credito assicurato da una buona parte della classe politica italiana: Berlinguer aveva, in certo senso, “occidentalizzato” il partito e creato una base di fiducia con gli altri partiti democratici della Repubblica. <72 Sull’organo di stampa comunista “L’Unità”, il giorno 30 luglio 1976, la prima pagina è dedicata alla nuova formazione del monocolore di Giulio Andreotti. Secondo il giornalista Claudio Petruccioli la DC stava prendendo atto della fine del suo “monopolio” in seguito ai risultati elettorali del giugno precedente. La DC aveva riconosciuto che: «Non esiste allo stato nel Parlamento italiano una maggioranza politica su cui fondare un governo con preminente responsabilità democristiana.» Grazie a questo riconoscimento, la DC non propone una maggioranza precostituita ma il programma e la struttura di un monocolore. Lo sviluppo positivo a cui l’articolo dava atto era la fine della discriminazione del Partito comunista, che ora invece presiedeva la Camera dei deputati e diverse commissioni permanenti. Anche gli altri partiti dell’arco costituzionale avevano rifiutato una maggioranza con la DC, e prendevano così parte alla formula delle astensioni. <73
Convocati quindi i sei partiti dell’arco costituzionale, La Malfa e Berlinguer discutono e trovano accordo sulla partecipazione comunista, che trova un prevedibile ostacolo nell’amministrazione americana di Ford <74 e in quella tedesca del cancelliere Schimdt. Così, matura la decisione del PCI di tenersi in disparte e nel mese di agosto del ‘76 viene formato un governo Andreotti, al quale il PCI prende parte con la particolare formula dell’astensione: con la garanzia di un coinvolgimento nelle decisioni, il PCI rimane nuovamente fuori dal governo dando inizio alla stagione della “solidarietà nazionale”. <75 Con la formula dell’astensione il PCI in un certo senso delude le aspettative del suo elettorato, proprio nel momento in cui questo gli aveva dato maggiore fiducia: prende piede in questo periodo un movimento di “dissenso” che aveva una matrice molto diversa da quella del ’68 e che protestava invece contro il PCI e lo stesso Berlinguer, e che ottenne come conseguenze l’avvicinamento di molti giovani a posizioni più estreme, come quelle delle Brigate Rosse, perché non si identificavano più nelle speranze riformiste del PCI, che venivano continuamente rimandate.76 La formula della solidarietà aprì una contraddizione interna al PCI, che si posizionò come partito in difesa dello Stato nell’emergenza terrorismo e che si affermò quindi come una parte della democrazia repubblicana, dando vita a una contraddizione identitaria. <77
[NOTE]
68 Barbagallo F., 2006, Enrico Berlinguer, Roma, Carrocci, p.231
69 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, pp.79-80
70 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, p.83
71 Barbagallo F., 2006, Enrico Berlinguer, Roma, Carrocci, pp.249-250
72 Guerra A., 2009, La solitudine di Berlinguer. Governo, etica, politica. Dal “no” a Mosca alla “questione morale”, Roma, Ediesse, p.184
73 Petruccioli C., 30 luglio 1976, Fine di un monopolio, in «L’Unità», n.206
74 L’elezione del democratico Jimmy Carter si svolgerà alla fine dell’anno 1976
75 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, p.90
76 Almagisti M., 2016, Una democrazia possibile: politica e territorio nell’Italia contemporanea, Roma, Carrocci, p.162-163
77 Pons S., 2006, Berlinguer e la fine del comunismo, Torino, Einaudi, p.157
Serena Nardo, Il ruolo del Partito comunista italiano nella Guerra Fredda: lotta per l’autonomia dalle superpotenze, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 2021-2022
#1976 #autonomia #crisi #DC #elezioni #EnricoBerlinguer #PCI #politiche #PRI #PSI #SerenaNardo #StatiUniti
Per quanto riguarda il Movimento giovanile democristiano, l’irrigidimento era palpabile
Gli eventi che vanno dal V congresso Dc di Napoli all’VIII convegno nazionale giovanile (Firenze, giugno 1955) sono come inscritti in un «piano inclinato», ove la «mutazione genetica» della Dc con l’andata al comando della «seconda generazione», quella di Iniziativa democratica, contribuisce ad accelerare le differenziazioni e, in una parte consistente, anche la dispersione di un patrimonio politico-culturale di generazione. Di fronte a un segretario, Fanfani, autoritario e organizzativista, accusato di voler usare il Movimento giovanile solo in senso attivistico-propagandistico, stanno ormai questi giovani che, in vario e articolato modo, gli si oppongono da «sinistra».
L’ultimo numero de «La Base» esce il 30 luglio 1954. Non è una chiusura imposta dall’altro, anche se nelle prime settimane di quello stesso anno la Direzione democristiana aveva affermato l’inammissibilità che su problemi di primaria importanza fossero espresse tesi non in linea col partito <678. Nonostante l’ingresso nel partito della seconda generazione di Iniziativa democratica e di alcuni elementi della terza, la Democrazia cristiana stentava a rinnovarsi e l’attivismo fanfaniano non si traduceva, per i basisti, nella costruzione di un moderno partito. A giudizio della Base era mancata, dopo il 7 giugno 1953 e il Congresso di Napoli, una riflessione profonda che non si riducesse unicamente alla difesa dell’unità del partito. Questo irrigidimento era d’altronde presente anche nel mondo cattolico. Nel 1954 Mazzolari tornava ad essere oggetto delle attenzioni del Sant’Uffizio: il 28 giugno il cardinale Giuseppe Pizzardo gli aveva vietato di predicare al di fuori della propria parrocchia. Un altro intervento punitivo fu rivolto contro don Milani, trasferito da Calenzano nel piccolo centro di Barbiana. Infine il presidente della Giac [Gioventù Italiana di Azione Cattolica], Mario Rossi, era costretto alle dimissioni.
Per quanto riguarda il Movimento giovanile, l’irrigidimento era palpabile: oltre al già citato deferimento ai probiviri di Arnaud, all’inizio del 1955 la Direzione, dopo la relazione di Fanfani sulle «questioni disciplinari», decide anche il deferimento di Amos Ciabattoni, reo, insieme al delegato regionale del Lazio Signorello, di aver diffuso un documento riservato assai critico sulla Dc e sul Movimento giovanile <679 di cui è venuta in possesso «l’Unità» che «ne ha tratto motivo per critiche al partito» <680.
Sul caso Rossi si esprime anche il quindicinale della Base con un articolo di Dorigo e con una lettera di Magri. Questa l’interpretazione del primo: “Il prof. Gedda sta giocando grosso e con l’avventato dilettantismo che distingue il suo comportamento in ogni campo ha voluto ad ogni costo far precipitare la situazione: si tratta, com’è chiaro, di una incosciente sfida alla stragrande maggioranza dei cattolici, i quali sanno vedere nel provvedimento preso nei riguardi generali della Gioventù cattolica lo squillo d’allarme più prepotente. […] Non è difficile né azzardato infatti collegare il siluramento di Rossi, come già quello di Carretto e dei suoi immediati collaboratori nell’ottobre del 1952, con la tenace, consapevole e logica resistenza della Gioventù d’Azione cattolica, in tutti i suoi quadri centrali e periferici, ad un andazzo che, precostituendo illecitamente in sede religiosa e con strumenti religiosi (tale è l’Azione Cattolica) scelte politiche di enorme portata, vuole imporre alla Dc, attraverso vie e uomini ben noti nella Dc, quella vera e propria strada sull’abisso alla quale l’apertura a destra e l’alleanza con le destre reazionarie monarchico-fasciste ci inchioderebbe senza possibilità di ritorno” <681.
Nella rubrica della rivista, “Voci dalla base”, si rendeva noto che la maggior parte delle lettere pervenute alla redazione conteneva pareri simili a quelli espressi da Dorigo. Nella sua lettera Magri analizza invece il comportamento della stampa di destra sul “caso Rossi”: “I quotidiani della destra hanno voluto affrontare la questione nel suo complessivo significato, anche religioso. Ed è questo molto significativo perché rivela l’intenzione precisa di compiere una identificazione semplice tra una determinata linea politica e la stessa ortodossia religiosa. È tutto lo zelo dei cattolici ferventi, la assillante preoccupazione per la salvezza della dottrina, la smania dell’ortodossia che, con un evidente equivoco delle competenze e di capacità i commentatori politici dei giornali reazionari invocano contro il modernismo e il deviazionismo in cui “necessariamente” cadono, a loro avviso, i giovani” <682.
In un documento “riservato” firmato Berlinguer, segretario della Fgci, e inviato a Luigi Longo, viene notato come proprio il caso Rossi abbia aperto un interessante dibattito «nonostante l’ingiunzione al silenzio dell’Osservatore Romano, sul periodico cattolico milanese La Base», «che si propone evidentemente di coordinare il movimento di diffuso malcontento esistente contro Gedda e di raggrupparlo attorno al gruppo più avanzato dei cattolici milanesi, così come ci è stato indicato in un colloquio che abbiamo avuto» <683.
È ancora Berlinguer, cogliendo l’occasione del “caso Rossi”, a scrivere a tutte le sezioni italiane della Fgci indicando che “la crisi della GIAC è uno degli aspetti del disorientamento esistente nel mondo cattolico in generale nel quale si combattono interessi diversi. Ad esempio vi è già fra i dirigenti giovanili ed anche tra alcuni anziani e sacerdoti la preoccupazione di trovare un accordo con noi. Per quanto riguarda i dirigenti diocesani noi abbiamo notizia che hanno espresso solidarietà al Rossi quelli del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia Romagna, di Siena, di Perugia e di Napoli. Posizioni di solidarietà si sono avute nella FUCI, nei Gruppi giovanili DC, tra i giovani delle
ACLI e della CISL […] la crisi della GIAC non ci ha preso alla sprovvista in quanto i motivi di contrasto, seppur in modo impreciso, li avevamo analizzati e non si può escludere che in parte al maturarsi dei contrasti tra i giovani cattolici abbia contribuito anche l’azione unitaria che da tempo andavamo sviluppando. La nostra posizione dopo la crisi di direzione è stata di simpatia e di cautela al centro e su scala provinciale, ricercando il contatto e la discussione, e di aperto intervento alla base, nel senso che abbiamo indicato la necessità che i giovani comunisti si recassero negli oratori della GIAC per discutere la questione” <684.
Quella che doveva essere una temporanea chiusura estiva, era divenuta per «La Base» una chiusura comunque definitiva. Qualche settimana più tardi veniva a mancare De Gasperi. Con la morte del leader trentino mutavano anche i rapporti di forza all’interno del partito; il successo di Iniziativa democratica si era tradotto nella vittoria di una corrente piuttosto che in un profondo cambiamento. Dietro la chiusura de «La Base» c’erano senza ombra di dubbio le pressioni di Fanfani, che avevano costretto i basisti a chiudere l’omonimo quindicinale e inaugurare una nuova esperienza editoriale, «Prospettive», come mezzo per difendere i valori dell’antifascismo, del rinnovamento del partito, della costruzione dello Stato democratico, della lotta ai monopoli e di un diverso anticomunismo. «Senza la collaborazione fra masse cattoliche e masse comuniste – scrivono ad esempio già nel secondo numero i redattori – la Resistenza non avrebbe avuto, come invece ha avuto, il significato di un risveglio della coscienza nazionale per la edificazione di un nuovo Stato»; «ora, nello escludere il comunismo italiano e nel mantenerlo fuori dallo Stato – proseguono – bisogna obiettivamente tenere conto che si esclude una forza componente della sua costituzione» <685.
[NOTE]
678 La Direzione, infatti, riteneva «assolutamente al di fuori di una seria vita democratica del Partito, la tendenza che va diffondendosi, di iniziative da parte di singoli o di gruppi di iscritti per la pubblicazione di fogli periodici rivolti soprattutto ad una polemica interna che assume talvolta asprezze tali da essere giustificata soltanto se fosse rivolta contro i nostri più violenti avversari. È urgente ricordare a tutti che la stampa di Partito per svolgere un’azione costruttiva deve essere legata a precise responsabilità di organi di Partito e mai alla fluida responsabilità di uno o pochi iscritti che agiscono senza un preciso mandato ufficiale»; ASILS, Dc, Dn, s.28, f.22, Verbale della riunione del 2 agosto 1954.
679 Nel documento firmato da Ciabattoni si sosteneva che «Da lungo tempo andava maturando la grave crisi del Movimento giovanile. Anzi, per usare una espressione più aderente alla realtà, da parecchio si sentiva l’esigenza di concludere, con grande cautela, ma ad ogni costo, il travaglio del Movimento giovanile. Dopo gli ultimi avvenimenti politici, infatti, si era maggiormente acuito il contrasto e il distacco tra il centro Nazionale e la Periferia (ciò anche per esplicita ammissione degli stessi Dirigenti Nazionali) e l’immobilismo tradizionale non trovava, ormai, più scusanti. […] I numerosi “ma che succede” e i “ma che cose dobbiamo fare” della periferia crediamo debbano essere tacciati. Non in un modo qualsiasi. Ma nell’unico modo dovuto: con poche parole e molti fatti, e soprattutto idee molto chiare. Non vorremmo si dimenticasse, nel frattempo, la precisa funzione del “reggente”: organizzare entro novanta giorni il convegno. Senza cioè possibilità di impostazioni determinate, avendo il Comitato affermato a maggioranza che resta valido l’impegno di sottoporre alla discussione del Convegno nazionale la linea politica e organizzativa fino ad oggi seguita dalla Direzione del Movimento. […] Alcune esigenze: legare la fiducia ai Dirigenti Nazionali e all’Esecutivo in carica […] Indipendenza del Movimento giovanile DC da ogni forma di “corrente” interna di Partito. […] Garanzia di libera azione al di fuori della semplice organizzazione del Partito. […] già nel Comitato Nazionale di Anzio del febbraio 1954, l’esigenza di una totale revisione della linea politica e organizzativa del Movimento era apparsa evidente. […] è cosa nota se si afferma che il nuovo Esecutivo non ha risolto nessun problema. I gruppi giovanili debbono infine rappresentare il punto di contatto più facile e più vicino con tutte le organizzazioni giovanili operanti»; cfr. ASILS, Dc, Dn, s.31, f.21, Verbale della riunione del 7 gennaio 1955.
680 Ibidem.
681 W. Dorigo, La sostituzione di Rossi alla Giac, in «La Base», n.7, 5 aprile 1954.
682 L. Magri, Nessuna complicità dei giovani, in «La Base», n.9, 5 maggio 1954.
683 APCIG, carte Fgci, b. 1954/2, f. 0423-2559, Note sul nostro lavoro verso i giovani cattolici, s.d. «La linea di azione che ci siamo fissati – prosegue il documento – nei giorni della crisi della Giac ci pare oggi ancora valida: appunto perché tra i giovani della sinistra cattolica vi è confusione e talvolta indecisione e timidezza, appunto perché vi è una situazione tale da prestarsi alle manovre degli ecclesiastici e di taluni uomini politici democristiani, occorre intervenire dall’esterno e dall’interno per rendere più rapido il processo di chiarificazione, per rendere più rapido il processo di chiarificazione, per incoraggiarli a resistere e a lottare dentro le fila del movimento democristiano. Un’azione più ampia verso al gioventù cattolica veniva iniziata dopo le note vicende della destituzione del dott. Rossi e della direzione centrale della GIAC. In questa occasione il Comitato Centrale, molte Federazioni e numerosi circoli svilupparono un lavoro di orientamento e di informazione verso la gioventù cattolica. Il risultato del lavoro svolto in questo periodo aveva anche un valore interno: infatti una maggiore sensibilità della gioventù comunista per il lavoro verso la gioventù cattolica è stata segnalata dopo questo periodo quasi ovunque. Il 18-19 giugno si riuniva a Perugia il Comitato Centrale della FGCI che, sulla base delle ultime nostre esperienze e delle indicazioni fornite dal compagno Togliatti al Comitato Centrale del Partito, impegnava tutta l’organizzazione della gioventù comunista a intensificare il lavoro per l’intesa fra la gioventù comunista e la gioventù cattolica. Nel corso di questi mesi, nonostante il massiccio intervento delle gerarchie ecclesiastiche e dei dirigenti fanfaniani della DC, si avevano numerosi casi di collaborazione su problemi diversi e in numerose città tra giovani dell’A.C. e democristiani e la gioventù comunista. Significative sono le adesioni di giovani dirigenti cattolici alla lotta in difesa della pace, contro la CED e il riarmo tedesco a Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Forlì, Siena, Trento, Bari, Messina, Rovigo».
684 APCIG, carte Fgci, b. 1954/2, f. 0423-2559, Lettera di Enrico Berlinguer alle sezioni della Fgci, s.d.
685 Provvedimenti anticomunisti, in «La Base», n.2-3, 25 dicembre 1954.
Andrea Montanari, Il Movimento giovanile della Democrazia Cristiana da De Gasperi a Fanfani (1943-1955), Tesi di dottorato, Università degli Studi di Parma, 2017
#1953 #1954 #1955 #ACLI #AmintoreFanfani #AmosCiabattoni #AndreaMontanari #AzioneCattolica #Base #cattolici #CISL #DC #don #EnricoBerlinguer #FGCI #FUCI #GIAC #giovani #giovanile #gioventù #MarioRossi #Milani #Movimento #PCI
Aldo Moro lasciò la corrente dorotea della Dc
L’Autunno caldo era solo la miccia della bomba presente nella polveriera italiana. Il resto dell’ordigno, che avrebbe dato il via ad anni di terrore, scoppiò poco dopo. Il 12 dicembre del 1969 all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura, in Piazza Fontana a Milano, si verificò un attentato nel quale rimasero uccise 16 persone e ferite oltre ottantotto. Del fatto furono frettolosamente incolpati gli anarchici, quando in realtà si scoprì seppur con ritardo che la mano dietro il detonatore era quella dei neofascisti e delle forze reazionarie del paese. La strage di Piazza Fontana, come scrive Salvadori, “aprì un capitolo tragico della storia italiana, segnato dal gonfiarsi sia di gruppi terroristici di destra sia di quelle extraparlamentari di sinistra votatisi entrambi all’eversione delle istituzioni” <196. Due movimenti anti-stato <197 presentatisi con ambizioni diverse, uno mirante all’instaurazione di uno stato autoritario e l’altro alla rivoluzione del proletariato, ma che finirono entrambi a condividere l’attacco al cuore dello stato, che avrebbe dovuto mettere al bando un sistema politico e partitico che non aveva saputo più rispondere all’esigenze di un paese insofferente sotto il profilo sociale ed economico.
Il secondo governo Rumor chiuse la sua esperienza nel febbraio del ‘70 circa due mesi dopo la strage di Milano. Il democristiano fu però reincaricato di formare un terzo esecutivo che guidò il paese fino al luglio dello stesso anno: vi parteciparono democristiani, repubblicani, socialisti e socialdemocratici. Le quattro forze politiche sottoscrissero in quei mesi una sorta di preambolo <198, redatto dal nuovo segretario Dc Forlani, che prevedeva l’allargamento della formula del centrosinistra anche alle amministrazioni locali. Una linea che ribadiva come obiettivo delle alleanze del centro-sinistra l’esclusione dal dialogo politico del Pci. Una scelta quella di escludere i comunisti che non apparve più accettabile agli occhi di Aldo Moro. L’ex segretario democristiano lasciò la corrente dorotea parlando di “tempi nuovi” <199 che dovevano mirare ad affrontare i problemi che avevano condotto operai e studenti a non sentirsi più veramente partecipi nella società. E fu su questa scia che Moro varò la “strategia dell’attenzione” <200 verso i comunisti al fine di aprire “un impegnativo confronto con il Partito comunista in ordine ai problemi vitali della società” <201.
Dopo Piazza Fontana, primo atto della “strategia della tensione”, una serie di azioni eversive iniziarono a farsi largo nel paese complici anche le incapacità di intervento dei governi. Nel dicembre del 1970, Junio Valerio Borghese già comandante della X Mas nella Repubblica di Salò insieme ad alcuni neofascisti, guardie forestali e con la complicità dei servizi segreti tentò l’occupazione del Viminale per dare luogo ad un golpe che però non riuscì. L’eversione della destra si fece ulteriormente sentire nelle rivolte di Reggio Calabria e dell’Aquila tra l’estate del 1970 e gli inizi del 1971 e al contempo andava sempre più rafforzandosi l’arcipelago di organizzazioni <202 della sinistra extraparlamentare che, complice anche l’erronea valutazione della loro pericolosità da parte dei vertici comunisti e socialisti, finirono ben presto per divenire un vero e proprio partito armato <203 che iniziò a macchiarsi di rapimenti e omicidi.
Nell’estate del 1970 a Rumor successe, alla guida di Palazzo Chigi, Emilio Colombo che diete vita a una “versione sempre più stanca del centro sinistra”204 che riuscì, nonostante le fortissime ostilità delle gerarchie democristiane, ad approvare la legge sul divorzio che era stata proposta dal socialista Fortuna e dal liberale Baslini e sostenuta da Pri, Psi, Psiup e Pci. L’approvazione della sola legge sul divorzio non appariva comunque sufficiente per valutare positivamente le esperienze dei governi di centro-sinistra succedutisi a partire dal 1968. A non sostenere affatto gli esecutivi furono anche i partiti che al loro interno, dopo l’avvio della V legislatura, registrarono scontri e situazioni difficili. Primi tra tutti i socialisti i quali dopo la sconfitta del Psu e la mancata partecipazione al governo di Giovanni Leone tornarono a sciogliere il partito ricostituendo il Psi e Psdi. La faticosa tela <205
intessuta da Nenni e Saragat iniziò a lacerarsi dopo meno di un anno proprio perché i socialisti e i socialdemocratici avevano voglia di tornare di nuovo alle urne – le amministrative e le regionali del 1970 – con i vecchi simboli e assetti politici. “Non è però possibile cancellare con un tratto di penna un percorso politico e fingere che nulla sia successo” <206 scrive la Colarizi a proposito del ritorno alle vecchie bandiere del Psi e Psdi. I socialdemocratici decisero di virare verso “destra” convinti che fosse giunto il momento di frenare la corsa delle sinistre più radicali e di ricostruire un argine al comunismo con un percorso diametralmente opposto alla nuova “strategia dell’attenzione” <207 varata da Moro e sposata dal Psi. Ovviamente lo scontro tra socialdemocratici e socialisti si consumava all’interno del governo determinando così “l’instabilità permanente della coalizione” <208.
Nel Psi l’uscita di scena di Nenni lascerà spazio a due nuovi leder: Mancini e De Martino i quali ritenevano necessario un nuovo percorso per far ripartire il partito senza però uscire dalla dimensione del governo che assicurava posizioni di potere <209 anche se queste non si rivelarono fruttuose al livello di voti. Per quanto concerneva l’area nella quale rintracciare nuovi consensi le idee di Mancini e De Martino sembrarono distanziarsi seppur mai entrare in contraddizione. Il primo riteneva che si dovesse guardare alle spinte moderne che arrivavano per lo più dall’elettorato giovanile, mentre il secondo guardava ai settori “più marcatamente politicizzati della sinistra” <210. Mancini e De Martino erano infatti convinti di riuscire a ottenere vantaggi politici ed elettorali dagli umori trasgressivi delle piazze con l’obbiettivo di “abbattere la barriera del centro-sinistra delimitato e apre il dialogo con il Pci” <211. La “strategia dell’attenzione” non sembrava lasciar dubbi sul fatto che l’isolamento del Partito comunista fosse ormai destinato a concludersi.
Il ritrovato spirito di collaborazione tra socialisti e comunisti giunse in un momento davvero cruciale per le vicende del partito-chiesa comunista il quale si trovava a dover fronteggiare la sempre più ampia radicalizzazione violenta della sinistra extraparlamentare che lo gettò, per tutta la V legislatura, nell’occhio del ciclone <212. Le scomuniche <213 non apparvero sufficienti a bloccare e riassorbire i fronti deviazionisti interni alla sinistra e per questo il riavvicinamento del Psi e la sempre più vicina fine dell’isolamento, dettata anche dall’inizio del dialogo con la sinistra cattolica, apparvero di fondamentale importanza per i vertici di via delle Botteghe Oscure che erano forti anche della costante crescita elettorale che gli proponeva come interlocutori ideali <214 seppur impossibilitati dal sedersi tra i banchi dell’esecutivo.
Simona Colarizi a questo proposito scrive: “La conventio ad excludendum resta insormontabile per i comunisti legati a Mosca […]. È però possibile ricercare intese sul programma, come sembra suggerire Moro con la fumosa formula della strategia dell’attenzione; governare attraverso preventivi accordi con l’opposizione che garantiscono alle leggi e ai provvedimenti varati dal centrosinistra un consenso o quanto meno un gradimento di quel 27% della popolazione controllato dal Pci <”215. Un’idea quella di Moro che troverà sponda nel mondo comunista dopo il 1972 quando, al XIII Congresso del Pci, venne eletto segretario Enrico Berlinguer che si presentò al mondo politico affermando: “In un paese come l’Italia una prospettiva nuova può essere realizzata solo con la collaborazione tra le grandi correnti popolari: comunista, socialista, cattolica. Di questa collaborazione l’unità di sinistra è condizione necessaria ma non sufficiente. […] Noi siamo disposti ad assumerci le nostre responsabilità” <216.
La Dc riteneva ben accetti <217 i voti comunisti seppur non tutti i vertici del partito condividessero la linea della sinistra cattolica e questo perché era sempre più evidente e forte la preoccupazione per i fermenti che si registravano all’interno del paese e la tensione crescente anche nell’estrema destra interna ed esterna al partito cattolico. Nel 1971 la Democrazia Cristiana aveva portato a casa l’importante risultato dell’elezione al Quirinale di Giovanni Leone che, scrive Gervasoni, “non era mai stato un grande sostenitore del centro-sinistra” <218. Leone introdusse nel dibattito politico temi importanti come quello della “saldatura tra coscienza morale e istituzioni” <219 ma la sua ascesa al Colle non diede nuova linfa né una ritrovata stabilità al governo Colombo. Proprio per queste ragioni nel febbraio del 1972 Giulio Andreotti venne chiamato a formare un nuovo governo che però non ottenne la maggioranza al Senato e costrinse Leone a sciogliere le camere e indire elezioni anticipate “diventando il primo presidente a far terminare una legislatura prematuramente” <220.
La fine non naturale della V legislatura, unitamente alle proteste sempre più violente e incontrollate interne al Paese, mise in evidenza la crisi di un sistema politico incapace, nonostante i reiterati tentativi del centro-sinistra, di dare risposte ad una società in continuo mutamento. Il terrore degli anni di piombo e gli eventi internazionali, verificatesi in luoghi molto lontani dalla penisola durante gli anni ‘70, posero i partiti dinanzi alla necessità, non più procrastinabile, di dare una svolta politica in grado di rinvigorire la democrazia italiana e mettere al riparo il sistema dal terrorismo nero e rosso.
[NOTE]
196 M. L. SALVADORI, Storia d’Italia, cit., p. 402.
197 Ibidem.
198 M. L. SALVADORI, Storia d’Italia, cit., p. 415.
199 Ibidem.
200 Ibidem.
201 Ibidem.
202 Ivi, p. 417.
203 Ibidem.
204 Ivi, p. 418.
205 S. COLARIZI, Storia politica, cit., p. 99.
206 Ibidem.
207 Ivi, p. 100.
208 Ibidem.
209 Ibidem.
210 Ibidem.
211 Ivi, p. 101.
212 S. COLARIZI, Storia politica, cit., p. 103.
213 Ibidem.
214 M. L. SALVADORI, Storia d’Italia, cit., p. 103.
215 Ibidem.
216 II testo della relazione in D. e O. PUGLIESE (a cura di), Da Gramsci a Berlinguer. La via italiana al socialismo attraverso i congressi del Partito Comunista Italiano, Edizioni del Calendario-Marsilio, Venezia, 1985, pp. 275-314.
217 S. COLARIZI, Storia politica, cit., p. 104.
218 M. GERVASONI, op. cit., p. 85
219 Ivi, p. 84.
220 Ibidem.
Marco Martino, Italia, Cile: destini politici e percorsi partitici alla base del Compromesso Storico tra PCI e DC, Tesi di Laurea, Università Luiss “Guido Carli”, Anno accademico 2019-2020
#1969 #1970 #1972 #AldoMoro #centroSinistra #crisi #DC #destra #divorzio #EmilioColombo #EnricoBerlinguer #eversione #extraparlamentare #Forlani #golpe #governi #Italia #Leone #MarcoMartino #moti #neofascisti #PCI #politica #Presidente #PSI #ReggioCalabria #Repubblica #Rumor #sinistra #terrorismo
Enrico Berlinguer: dopo quarantuno anni è sempre più attuale https://www.articolo21.org/2025/06/enrico-berlinguer-dopo-quarantuno-anni-e-sempre-piu-attuale/ #enricoberlinguer #Articoli
Per me il ricordo di #EnricoBerlinguer è sempre, prima che politico, umano. Ancora oggi, dopo tanti anni, la sua vita, la sua lotta mi commuovono. E le sue parole sono uno sprone a continuare le battaglie che aveva portato avanti con determinazione.
Cosa resta oggi di quel popolo, di quel sentimento politico, di quell’identità?
#la7 #latorredibabele #enricoberlinguer
https://magtv.altervista.org/speciale-la-torre-di-babele-su-la7-gli-ultimi-giorni-di-enrico-berlinguer/
Il film racconta la vita e la visione politica di uno degli uomini più amati e discussi della storia italiana.
#skycinema #enricoberlinguer #eliogermano
https://www.teleblog.it/436530/sky-canali-tv-2/elio-germano-nei-panni-di-enrico-berlinguer-su-sky-cinema.html
E quelli ti rispondono: «Vabbè ma tu il film lo hai visto?» No, non l'ho (ancora) visto però intanto è un fatto che #lagrandeambizione sia il compromesso storico, che si scelga solo il periodo che va dall' colpo di Stato in #Cile del 1973 al sequestro di #AldoMoro del 1978 e poi ci sono importanti rilievi di #LucianaCastellina... #EnricoBerlinguer https://jacobinitalia.it/berlinguer-la-grande-rinuncia/
Saw the #Film about Italian #communist party leader Enrico #EnricoBerlinguer last week. It’s very well done even if Berlinguer came across as being rather ordinary as well as being a family man. He was very well respected and sadly died suddenly.Have been trying, and failing, to find out more about Italian communist party #policy. #communism
Il #6ottobre 1977 uscì Berlinguer ti voglio bene, il primo indimenticabile film di #giuseppebertolucci che lanciò #robertobegnini https://www.lasinistraquotidiana.it/berlinguer-ti-voglio-bene-la-dimensione-genitale-e-lutopia-comunista/
#AccaddeOggi #unocinema #Berlinguer #enricoberlinguer #film #movie #moviescenes #filmphotography #filmcommunity #filmphoto
Enrico Berlinguer e un orologio fatto come lui
🛑 Una scelta imprevista e inevitabile 🇬🇧 🇫🇷 🇪🇸 🇩🇪 🇮🇱 🇨🇳 translation on site👇 https://wp.me/pey833-5mg
https://boomerissimo.it/2024/06/22/lorologio-enrico-berlinguer-esattamente-quello-che-ti-aspetti/
#boomerissimo #pci #EnricoBerlinguer #orologi #seiko5 #seiko
Il significato di #EgemoniaCulturale è questo: a filmare l'addio a #EnricoBerlinguer c'erano Bertolucci, Benigni, Lizzani, Scola, Maselli, Montaldo.. https://inv.tux.pizza/watch?v=hVBujn9o-J8 #accaddeoggi
La "questione morale" non credo significasse solamente non rubare. Era anche avere un comportamento (un tenore di vita) che fosse in sintonia con ciò che si diceva e con coloro che si dichiarava di difendere. Veramente un altro mondo. #EnricoBerlinguer moriva 40 anni fa. https://close-up.info/biografilm-xx-edizione-bologna-7-17-giugno-prima-della-fine-gli-ultimi-giorni-di-enrico-berlinguer-di-samuele-rossi/ Grazie a https://mastodon.uno/@CiCa #accaddeoggi #politica
“Vogliamo una società che rispetti tutte le libertà, meno una: quella di sfruttare il lavoro di altri esseri umani, perché questa libertà le altre distrugge e rende vane”
L’#11giugno di 40 anni fa la scomparsa di #EnricoBerlinguer, tra i leader politici più amati della storia repubblicana.
Heute jährt sich der Todestag von #EnricoBerlinguer zum 40. Mal. Klaus Bullan über Berlinguers dritten Weg zum Sozialismus und seine Bedeutung für die Linke heute. 👇 #Italien
https://www.rosalux.de/news/id/52164
“Il firmamento bruciava” alla morte di Enrico Berlinguer e brucia ancora https://www.articolo21.org/2024/06/il-firmamento-bruciava-alla-morte-di-enrico-berlinguer-e-brucia-ancora/ #enricoberlinguer #Articoli
Il #7giugno 1984 a Padova, nel corso di un comizio, #EnricoBerlinguer, segretario nazionale del Pci, viene colpito da ictus. Continua a parlare finché sviene. Morirà pochi giorni dopo, l'11 giugno.
Attentato a Berlinguer
🛑 Due inchieste rivelano la verità 👇
#boomerissimo #enricoberlinguer #misteriitaliani #guerrafredda #PCI #storia